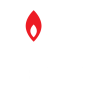Lettere, pacchi, visite Lettere, pacchi e visite rappresentavano le gioie più grandi per i detenuti nei campi di lavoro staliniani. Le lettere dei parenti ti aiutavano a credere che non ti avessero dimenticato, i pacchi di alimentari aiutavano semplicemente a sopravvivere e le rare visite, quando avvenivano, erano felicità pura. —————- David Budënnyj (1930-2011) è stato arrestato nel 1950 con l’accusa di aver fatto parte dell’organizzazione giovanile “Unione Comunista della gioventù” e condannato a cinque anni di ITL [Isprovitel’no- Trudovye Lagerja, campi di lavoro correzionale], che ha scontato nei campi del Kazakistan. È stato riabilitato. Insegna all’università di Voronež ed è dottore in scienze economiche. All’inizio ero in isolamento, da solo. Per un mese, probabilmente. Solo. Fino a quei giorni di tensione durante i quali si è svolta l’inchiesta. Poi ne hanno messi lì altri. Lo guardo: un altro. Eravamo già in quattro e c’era anche un tipo, non ricordo il nome, uno capace. Giusto, era così. “Sai, si può scrivere alla mamma. Si può provare. Un biglietto”. Io dico “Come?”. “Ascoltami. Scrivi quello che vuoi. In ogni caso, scrivi in modo tale che neanche una parola si ritorca contro di te. Per esempio, non scrivere «Abbasso Stalin» o cose del genere”. In parole povere, non bisognava danneggiare se stessi ancora di più. “Ma come si fa a consegnarlo?”. Tu scrivi. Qualcuno ha una matita chimica e qualcun altro ha della carta… Io ho scritto il biglietto. “E ora?”. “Ecco, ora guarda”. Ha rovesciato il sacchetto che conteneva tutte le cose che mi avevano portato. Rovesciato. Quindi, sul fondo/, questo/ha nascosto il mio biglietto e ha rovesciato di nuovo il sacchetto. No, no, non ancora. Il biglietto era fissato, così non si rovesciava, era cucito. Qualcuno aveva ago e filo. I detenuti/come? Ogni giorno c’era la perquisizione. Però qualcuno ci riusciva lo stesso. Erano svegli. C’erano ago e filo. Era cucito sul fondo. Per esempio un centimetro e mezzo, forse. Il meno possibile, perché non si notasse. Lo si cuciva. Il sacchetto veniva rivoltato dalla parte giusta. Ed era vuoto. Nikolaj Nastjukov è nato nel 1933 a Pavlovsk, nell’oblast’ di Voronež. Nel 1952 è stato arrestato con l’accusa di aver fatto parte di un’organizzazione giovanile antisovietica di stampo terroristico. Condannato a otto anni di ITL, ha scontato la pena in un Rečlag a Vorkuta. È stato riabilitato. È dottore in scienze biologiche. Vive a Voronež. Sì, si poteva ricevere visite ma erano molto brevi, circa, circa dieci minuti. Ecco, da un lato c’era una, una reticella; lì stavano i parenti, la mamma, in lacrime, andava lì, all’interno, nello spazio dove c’era la sentinella, intendo, o qualcuno/. Di solito un poliziotto o una sentinella, lì nello spazio gridavo qualcosa anch’io/. I.O. E non si sentiva niente. N.N. La mamma piange, è in lacrime, è ovvio cosa le dici, là. Sì, “va tutto bene”, tutto qui, ecco. Là gridi una cosa qualsiasi, tutto qui. Una visita c’è stata. Susanna Pečuro è nata a Mosca nel 1933. È stata arrestata nel 1951 all’età di 17 anni in quanto membro dell’organizzazione giovanile “Unione lotta per la causa della rivoluzione” e condannata a 25 anni di ITL. Ha scontato la pena nei campi di Inta, Abez’, e nella prigione della centrale di Vladimir fino al 1956. Riabilitata, è storica e archivista. Vive a Mosca. Mi hanno portata davanti alla commissione medica prima del trasferimento. Il medico ha guardato e ha detto: “Allora, dunque, è uno scompenso. Ha un edema polmonare. Eh, dove la manderanno? Come farà ad arrivarci? Chi vive con lei?”. Io dico: “la mamma”. “Dove vive?”. E dopo qualche giorno mi hanno detto: “Senza roba”. E mi hanno portato al colloquio con mia mamma, alla quale avevo detto che andava tutto bene, che ci trattavano bene, tutto perfetto. La mamma non ha pianto, è rimasta lì tutta impietrita. Una visita di quindici minuti. Elena Markova è nata nel 1923 a Kiev. I genitori sono stati perseguitati, il padre è stato fucilato nel 1937. Tra il 1941 e il 1943 ha vissuto nella zona di occupazione nell’oblast’ di Doneck. Dopo la liberazione dell’oblast’ da parte dell’esercito sovietico è stata arrestata da organi dell’NKVD e condannata a 15 anni di lavori forzati. È stata rinchiusa nel campo di Vorkuta per 10 anni e riabilitata. È dottore in Scienze Tecniche. Vive a Mosca. Sono finita a Vorkuta. Non mi hanno concesso un incontro con mia mamma. Anche questa è una cosa talmente atroce. Quindici anni di lavori forzati. Mamma è venuta in carcere, ma non le hanno permesso di avere nemmeno un incontro di addio con me. Ol’ga Cybul’skaja (Sorokoumova), nata nel 1935 a Frunze, è figlia di perseguitati. Il padre è stato fucilato, la madre ha scontato una pena detentiva nel campo di Akmolinsk per le mogli dei traditori della patria. È ingegnere-chimico. Vive nella città di Korolev, oblast’ di Mosca. La mamma è tornata, ci avevano cacciati, vivevamo nell’appartamento del direttore a Frunze, ci avevano cacciati nel chiosco. Sedevamo sui fagotti e la mamma ha iniziato la ricerca febbrile di un alloggio da qualche parte. E l’ha trovato in una zona molto, molto periferica di Frunze. Ci ha portato lì, poi lei è andata a far visita a papà. E ha portato tutto quello che riteneva necessario: vestiti di lana, l’orologio e tutto, cioccolato, e quando ha visto papà, lei l’ha guardato e ha visto che esteriormente era molto cambiato. Aveva le dita completamente blu. Evidentemente erano i segni delle torture subite. La mamma gli si è gettata addosso dicendo: “Griša, ti ho portato tutto”, lui dice: “Nadja, e da fumare?”. Lei dice: “Griša, l’ho dimenticato, domani te lo porto”. Ma lui sapeva già che l’indomani l’avrebbero fucilato, era stato avvertito. Nikolaj Nastjukov In un campo c’era, per esempio questa procedura. Il capo della sezione speciale, per non, diciamo, stare lì a rompersi le scatole, aveva dei moduli già preparati: “Sto bene, non mi serve niente. Spedite il pacco”. Così non doveva controllare ogni lettera scritta dai detenuti,… Continua a leggere Gli ultimi testimoni. Intervista
Tag: Elena Markova
Gli ultimi testimoni. Intervista
Il lavoro femminile nei campi Le donne, nei campi di lavoro staliniani, svolgevano le stesse mansioni degli uomini, nelle miniere, nel disboscamento, nelle costruzioni… Ma per le donne, che il campo privava della famiglia e della giovinezza, tali mansioni non erano soltanto gravose. Il lavoro comportava umiliazioni e violenza. ——– Elena Markova è nata nel 1923 a Kiev. I genitori sono stati giustiziati; il padre mediante fucilazione nel 1937. Tra il 1941 e il 1943 ha vissuto nella zona di occupazione nell’oblast’ di Doneck. Dopo la liberazione dell’oblast’ da parte dell’esercito sovietico è stata arrestata da organi dell’NKVD e condannata a 15 anni di lavori forzati. È stata rinchiusa a Vorkuta per 10 anni e riabilitata. È dottore in Scienze Tecniche. Vive a Mosca. La questione “uomo-donna” per noi era molto penosa. Le ragazze giovani cedevano subito a certe condizioni quando, ecco, i superiori, uomini, avanzavano determinate pretese. Se rifiutavi ti facevano scendere in miniera. E io scendevo molto velocemente, in miniera. E lì, sottoterra, ho svolto un lavoro per me nuovo, sui vagoncini. Allora non c’erano i cavalli sottoterra, negli anni di cui stiamo parlando. Sono comparsi dopo e i forzati, insieme ai cavalli, spingevano i vagoncini con il carbone attraverso la galleria. Io ero tra questi. Oppure si costruiva la ferrovia. Anche questo, tra l’altro, era una lavoro orribile. Sembrava già una buona cosa non lavorare in miniera. Com’era? Costruivamo una ferrovia che si allontanava sempre più dalla nostra zona. Quindi dovevamo camminare, camminare e camminare fino al luogo di lavoro. Alla fine facevamo dieci chilometri per arrivarci e lavoravamo per dieci ore all’aria aperta per costruire questa ferrovia. Poi, dieci chilometri per tornare. Non si trattava della miniera ma in superficie, per la ferrovia. Ma ci stancavamo così tanto, me lo ricordo ancora benissimo come se fosse adesso. Dieci chilometri all’andata e dieci al ritorno, con abiti pesanti, portandosi dietro i badili. Siamo caduti esanimi sulle cuccette senza neanche svestirci. Esanimi. I primi giorni non andavamo nemmeno a cena o a pranzo. Ci davano pranzo e cena insieme. Non avevamo la forza di andare alla mensa. Ioanna Murejkene (Ulinauskajte) è nata nel 1928 a Kaunas. Nel 1944, dopo il ritorno dell’esercito sovietico, ha appoggiato la resistenza antisovietica. È stata arrestata e condannata a 10 anni di campo di lavoro correzionale, scontati a Komi, Tajšet e Noril’sk fino al 1956. Ha partecipato attivamente alla rivolta del campo di Noril’sk. È una pediatra e vive a Vilnius. In generale lavoravamo in condizioni molto, molto dure. Ci portavano a scavare la torba. D’inverno bisognava scavare nella neve, ma la torba non gela, non gela. All’inizio trovi uno strato ghiacciato, poi trovi la torba tiepida. Non gela. A che scopo si scavava non si sa. Probabilmente ce la facevano scavare solo per farci lavorare. Si scavava questa torba bagnata con gli stivali, bagnati anch’essi, fradici. Stavamo tutto il giorno in quel pantano. Poi si tornava a casa, gli stivali gelavano. Non è facile raccontare. Arrivi е non c’è un posto in cui asciugarsi, di giorno bisogna far asciugare un po’ i vestiti e tutto il resto vicino alla stufa e alle botti. Noi lavoravamo là, abbattevamo gli alberi del bosco, li tagliavamo. La quota di produzione era molto alta. Bisognava abbattere sei pini alti con la sega manuale. Non meccanica, manuale. Gi-ru-gi-ru.. Si lavorava così, sa, poi si abbattevano. Fatto ciò, bisognava staccare i rami, in modo da poter tagliare l’albero in tre pezzi da sei metri e mezzo, tre pezzi. Sei pini così, era questa la norma. Un lavoro molto duro. Vera Jul’evna Chudjakova (Gekker) è nata a Potsdam nel 1922. In quello stesso anno, la famiglia si è trasferita nella Russia sovietica. Nel 1938 il padre è stato fucilato e la madre arrestata. Le sorelle Marsella, Alisa e Vera, studentesse al conservatorio, sono state arrestate nel settembre del ’42 e condannate a 5 anni. Vera ha scontato la pena nei campi di Kirghizistan, Uzbekistan, Siberia e Kazakistan. È un’insegnate di musica. Vive nell’oblast’ di Mosca. Certo, c’erano le norme. Ma il lavoro che facevo io non poteva avere alcuna relazione con le norme perché non si tratta di norme, in genere era così. cosa può fare, mettiamo, una donna malata o un’anziana o persone così? Noi non avevamo norme da rispettare. Semplicemente ognuno scavava come poteva. Si faceva molto poco, molto poco. Anna Matljuk (Peca) è nata nel 1927 nel villaggio di Tiškovcy, regione di Gorodenskij, oblast’ Stanislavskaja. Nel 1944 è stata arrestata con l’accusa di partecipazione a un’organizzazione ribelle ucraina e condannata a 10 anni di ITL. Ha scontato la pena partecipando alla costruzione del cantiere n. 501 e dopo la chiusura è stata trasferita nel Osoblag (regione di Irkutsk) per svolgere lavori edili generici. Riabilitata, ha lavorato come bambinaia negli asili nido. Vive nella città di Pečora, repubblica di Komi. Ci hanno portati fino al cantiere 501. Là c’erano 50-60 gradi sotto zero. Faceva un freddo terribile. E noi camminavamo. Ogni giorno c’era un controllo, per verificare che ci fossimo tutti, che eravamo arrivati vivi. Si vedeva solo la parte in basso, le facce no. Un gelo talmente forte e una tale brina. Immagini: le donne portavano le rotaie, spianavamo la strada. Per fare arrivare la ferrovia. La strada era tracciata, un po’. Sono arrivati i mezzi girevoli con sabbia e ghiaia e noi, per due giorni, abbiamo continuato a scaricarli nello stesso luogo. Andava a finire tutto da qualche parte, ecco, come un fiume, un ruscelletto. E noi trasportavamo le rotaie. Ricordo circa 19 ragazze, hanno preso 19 donne. In verità c’era un uomo, il capocantiere, no il caposquadra. Era il caposquadra. Aveva una certa asta. Misurava tutto. Аbbiamo posizionato le traversine. Tutte. Ecco, è così che ho scoperto quanto siano leggere le rotaie. Elena-Lidija Posnik (Koz’mina) è nata nel 1924. Nel 1945 è stata deportata e condannata a 15 anni di lavori forzati. Ha scontato la pena nell’oblast’ di Archangel’sk, regione di Krasnojarsk, e nella Kolyma. Riabilitata, ha lavorato come insegnante di tedesco. Vive… Continua a leggere Gli ultimi testimoni. Intervista
Gli ultimi testimoni. Interviste
Elena Markova ricorda: forzata Elena Markova è nata nel 1923 a Kiev. I genitori sono stati vittime di repressioni, il padre fucilato nel 1937. Nel 1941-43 si trovava nel territorio occupato della regione di Doneck. Dopo la liberazione della regione da parte dell’esercito sovietico è stata arrestata dagli organi dell’Nkvd e condannata a 15 anni di lavori forzati. Per 10 anni è stata detenuta al Vorkutlag. Riabilitata. È dottore in scienze tecniche. ——— Be’, se parliamo della rovina di quella generazione, dunque mio papà, insegnante, è stato sottoposto a repressioni e fucilato nel ’37, durante il grande terrore. La mamma è stata arrestata nel ’38. Ed ecco mi hanno proposto di scrivere una dichiarazione per il giornale murale, che rinnegavo i miei genitori e così via, che ero una patriota. Ma non l’ho fatto. Inizio della II guerra mondiale. La vita sotto l’occupazione E così, l’inizio della guerra. Naturalmente era svanito il mio sogno di andare all’università. Nonostante fossi figlia di una vittima delle repressioni, allora non capivo che forse all’università non mi avrebbero preso. Dunque, avevano ceduto il Donbass senza combattimenti. Perciò sulla linea del fronte, ecco, quando i tedeschi avanzavano e noi ci ritiravamo, non capivamo neanche cosa stesse succedendo. Non tutti gli ebrei sono riusciti a sfollare, perché semplicemente non c’erano mezzi. Be’, a piedi, andavamo a piedi. Ed ecco un altro dettaglio di una famiglia ebrea che conoscevamo bene. Li ricordo dall’infanzia, erano molto amici del papà e della mamma. C’erano due sorelle, medici. Hanno caricato un po’ di masserizie, sono partiti. C’era un cavallino, o due. Dopo aver fatto un po’ di strada, si è scoperto che davanti c’erano già i tedeschi. Sono tornati. Ed ecco, quando sono tornati, e qui erano già arrivati i tedeschi, mi hanno chiesto di abitare per un po’ da loro, così, se fossero arrivati i tedeschi, avrei aperto io la porta, e non loro. Be’, pensavano che comunque il pericolo c’era, ma se ci fosse stata una bambina russa, i tedeschi se ne sarebbero andati subito. Nessuno capiva la situazione reale. Ed ecco, per qualche tempo ho abitato da loro. Poi naturalmente li hanno poratati via comunque, e sono morti. Febbraio, doveva essere l’undici febbraio. C’è stato lo sfondamento del fronte già nel punto dove vivevamo noi. Era il Donbass, la città di Krasnoarmejsk. E io sono corsa fuori in via Lenin, e là i feriti erano distesi semplicemente per strada. Non c’era nessun battaglione sanitario, nessuna infermiera. La gente perdeva sangue, gridava, e nessuno la salvava. Ho cominciato a trasportare i feriti nell’edificio del nostro poliambulatorio cittadino, che si trovava alcune vie più in là, in via Sverdlov. Mi è venuta subito l’idea che comunque quello era un istituto medico, bisognava salvare le persone e trasportarle là. Là ho dato loro da bere, li ho medicati, li ho consolati in qualche modo. C’era questo gruppo di feriti in quell’edificio vuoto del poliambulatorio, dove ho cercato di soccorrerli. E poi, già dopo qualche ora, è arrivato ufficialmente il battaglione sanitario. E così c’è stato lo sfondamento del fronte, e la battaglia per la città è continuata ancora. Una parte della città era delle truppe da sbarco, e una parte della città era dei tedeschi. E noi non abbiamo fatto in tempo a guardarci intorno, che qualcuno ha gridato alla finestra: «Arrivano i carri armati tedeschi!» Li chiamavano “tigri”. Che fare? Alcuni erano feriti leggermente, potevano camminare, ma una parte erano feriti gravemente. Così è maturata un’idea. Di notte, attraverso l’uscita posteriore, perché davanti a quella principale c’era una guardia, cercare di dare la possibilità di fuggire ai feriti meno gravi, perché si nascondessero dalla popolazione locale. Allora non c’erano passaporti, c’erano gli Ausweis. Erano dei certificati che rilasciava l’ufficio di collocamento. Be’, come un attestato che eri residente in quel luogo. Alla fine di marzo sono andato a lavorare all’ufficio di collocamento. E in agosto c’è stata la definitiva liberazione di quella località dai tedeschi. Cioè, ho lavorato là per un periodo piuttosto breve. Ma per quel periodo davvero mi sono procurato quegli Ausweis, anche se c’era pericolo di morte, per quei documenti falsi. E tutte le persone nascoste da noi sono state salvate. Fine dell’occupazione. Primo arresto. Dunque, è finita l’occupazione, sono arrivate le nostre truppe. Be’, qui, se fossi stata un po’ più intelligente, un po’ più calcolatrice, non avrei fatto il passo che, sconsideratamente, ho fatto. Che cosa ho fatto? La popolazione del territorio occupato non aveva diritto di spostamento, quando i nostri hanno occupato quelle truppe. Perché hanno iniziato le verifiche, là c’erano nemici del popolo, traditori della patria, traditori. Non lasciavano muovere un passo a nessuno, cioè trasferirsi in un’altra città. E a un tratto mi vado io stessa a cacciare in quelle fauci, e dico: datemi il permesso di andare a studiare all’università. Naturalmente non mi danno nessun certificato. Ed ecco mi sono ritrovata in quello scantinato, al mulino, alla fabbrica di farina, nel reparto femminile. E vicino c’era un enorme locale sotterraneo, dove si trovavano gli uomini. Tutti stipati come sardine in un barile. Non c’è acqua, non c’è cibo, non c’è niente. E la gente non capisce, come all’inferno: che cosa succederà? Non si respira. È uno scantinato. Dunque, condizioni assolutamente antigieniche. E mi è venuta l’erisipela, un’infiammazione alla gamba. Perché stavamo in un tale sudiciume, che è cominciata anche la dissenteria, e Dio sa cosa. E a me è venuta l’erisipela. Secondo arresto e inchiesta E mi trovo a casa sotto cauzione, ma mi sembra che debba esserci stato un errore, io non ho nessuna colpa, ho salvato delle persone, devo andare all’università. Mi sembra perfino inverosimile. Era mai possibile che non capissi niente a questo modo, e solo perché volevo studiare, che agissi per la seconda volta allo stesso modo, quando la prima volta mi avevano già arrestato? E andai una seconda volta. Ma è andata ancora peggio. Dunque, mi gettarono in una fossa. In una parola, per quell’episodio, che avevo lavorato come interprete all’ufficio… Continua a leggere Gli ultimi testimoni. Interviste