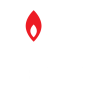(Intervista di Francesco Brusa a Igor Cașu, direttore del Centro Nazionale degli Archivi della Moldova; immagine: We moved to 8.12, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)
18 dicembre 2024
ore 12:23
Tra ricordi privati e memoria pubblica: il passato diviene molto spesso un terreno di scontro e di strumentalizzazione, oppure un elemento su cui fondare identità nazionali e appartenenze collettive. Con l’invasione russa in Ucraina, in particolare, si è prodotto un acceso dibattito su diverse questioni storiche che rimontano fino alla Seconda guerra mondiale (o addirittura prima) e che non coinvolge solo i paesi interessati dalla guerra ma, a vario grado, società e comunità che hanno fatto parte dell’Unione Sovietica e che ancora vivono alcuni degli effetti di quell’esperienza.
Nella repubblica moldava, in maniera forse meno eclatante di quanto è successo nella vicina Ucraina con l’Holodomor (o comunque al di fuori di un così serrato scrutinio internazionale), si è per esempio avviato da un paio d’anni un processo di riconoscimento istituzionale della carestia del 1946-47: un periodo di acuta penuria di generi alimentari, che ha colpito diverse zone dell’Urss ma che in Bessarabia ha ucciso secondo le stime più caute un numero pari al 5% della popolazione dell’epoca (123.000 decessi, cifra su cui concorda la comunità internazionale degli storici).
Ne abbiamo parlato con Igor Cașu, direttore del Centro Nazionale degli Archivi della Moldova, storico e autore, tra le altre sue opere, del libro Duşmanul de clasă. Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A)SS Moldovenească (Chișinău: Cartier, 2013, “Nemici di classe. Repressioni politiche, violenza e resistenza nella Repubblica Socialista Autonoma della Moldova”).
La carestia in Bessarabia: una tragedia dovuta a circostanze esterne o un crimine pianificato?
Il problema che pone la carestia nei territori della ex-repubblica socialista moldava è dato dall’altissimo numero di morti in relazione alla popolazione totale. Se prendiamo le carestie del 1946-47, vediamo che il numero dei decessi in Ucraina è pari a circa l’1% degli abitanti di allora, mentre in Russia arriviamo a circa lo 0,6%… In Moldova, stando proprio alle stime più prudenti su cui c’è un consenso pressoché totale fra gli storici, parliamo invece del 5%: praticamente dieci volte tanto che in Russia. Si tratta di una sproporzione che merita di essere spiegata e le cui responsabilità vanno investigate.
In questo senso, credo che la categoria di “genocidio” (che viene usata da alcuni) sia fuorviante, perché si basa su un’intenzionalità che è impossibile da dimostrare. Manca, inoltre, una chiara progettualità: perché poi, dopo il 1947, si è fermata? Ci sono dunque categorie più specifiche e a mio modo di vedere più utili per spiegare quanto è successo, senza per questo dover essere meno critici verso il regime sovietico: negligenza criminale da parte dello stato, o simili. Insomma, le autorità che controllavano a quel tempo il territorio erano responsabili dell’incolumità delle persone che lo abitavano. Che cosa è successo, dunque? La ricerca storica, incrociando i documenti e i dati, deve rispondere a un tale quesito.
Si tratta di un evento che non è sempre stato facile da investigare…
Da un punto di vista personale, il mio primo contatto con la “storia proibita” del periodo sovietico è avvenuto verso la fine degli anni Ottanta, quando in casa mia arrivavano giornali come “Union” e “Republican” in cui si poteva leggere qualcosa del Grande Terrore e delle repressioni staliniane. Sono cresciuto in un’area rurale in quello che allora era il distretto di Comrat (sud della Moldova) e avevo diciotto anni al momento del crollo dell’Urss.
Poco dopo l’indipendenza, nel 1992, è stata approvata una legge molto progressista in termini di rielaborazione del passato, che garantiva l’accesso agli archivi di stato, alle informazioni riguardanti sia le vittime che i perpetratori dei crimini di epoca sovietica e al tempo stesso poneva le fondamenta istituzionali per la riabilitazione delle vittime della repressione. Ma poi, appena due anni dopo, le forze comuniste sono tornate al governo e in particolare dal 1998 in avanti con l’era di Volodimir Voronin era estremamente difficile fare ricerca in quell’ambito e portare avanti iniziative pubbliche che riguardassero il passato sovietico.
Dunque, esisteva un impianto legislativo molto progressista, ma per molto tempo è mancata la volontà politica. Infine, in seguito alla cosiddetta “Twitter Revolution” del 2009 e il cambio di governo l’anno successivo, c’è stata una svolta: sotto la presidenza ad interim di Mihai Ghimpu (il cui fratello Gheorghe era stato un dissidente legato al Partito di Rinascita Nazionale) è stata creata una commissione per l’indagine dei crimini sovietici, di cui ho rivestito il ruolo di vicepresidente in un paio di occasioni. Si è avuto finalmente accesso ai documenti del Kgb, dell’Nkvd così come ad alcuni atti ufficiali del partito comunista sovietico locale.
Cosa ha comportato un tale processo in termini di memoria pubblica e di ricezione da parte della società di eventi come le deportazioni o la carestia del 1946-47?
Grazie al lavoro della commissione, sotto il governo di Vlad Filat hanno avuto luogo le prime commemorazioni pubbliche di quegli eventi che si sono tra l’altro svolte alla presenza delle autorità di altri paesi. Devo dire che la carestia ha sempre mantenuto un posto defilato nella percezione comune e nella memoria nazionale sul passato sovietico. Da una parte, è fisiologico: le deportazioni sono un fenomeno più direttamente comprensibile ed esperibile da parte delle persone comuni, anche solo per il fatto che alcuni deportati hanno fatto ritorno in Moldova dopo il crollo dell’Urss. Inoltre, già durante la perestrojka, se ne discuteva. Dall’altra parte, credo che però la carestia dovrebbe rivestire un ruolo più centrale perché comunque ha rappresentato un evento più tragico in termini di perdita di vite umane.
Tuttavia, costruire una memoria nazionale condivisa e cambiare la percezione generale non è un processo immediato. Quando nel 2010 si è potuto accedere agli archivi e si è potuto di conseguenza presentare documenti e prove della veridicità di certe tragedie del nostro passato presso l’opinione pubblica, non c’è stata chissà quale reazione. Parlo del mio punto di vista, ma credo che sottovalutiamo spesso come una buona parte della società moldava viva ancora immersa in uno “spazio di senso” ereditato dall’Unione Sovietica, che implica la presenza di un certo tipo di informazione, di attitudine verso la storia e la persistenza di un certo immaginario che non scompaiono da un giorno all’altro.
A ogni modo, due anni fa è stato istituito un giorno ufficiale per commemorare la carestia. Si è trattata soprattutto di un’iniziativa portata avanti da Vasile Șoimaru, ex-professore di economia dell’attuale presidente Maia Sandu e uno dei rappresentanti della memoria nazionale del 1989 nelle fila del partito di governo. Penso sia anche una decisione presa sulla scorta dell’emozione prodotta dall’invasione russa in Ucraina e la considero un buon passo in avanti. Insisto però, come dicevo in apertura, sul fatto che secondo me occorre sempre stare attenti alle parole e a utilizzare un linguaggio il più possibile specifico e neutro: se con la carestia possiamo parlare di un crimine contro l’umanità perpetrato dal regime sovietico, magari anche con conseguenze genocidarie, non possiamo parlare di genocidio in senso stretto dal momento che non è dimostrabile l’elemento intenzionale.
Esiste, dal suo punto di vista, un paradigma storico più corretto di altri per costruire un’identità nazionale in Moldova?
È una questione complessa. Negli ultimi duecento anni sul territorio dell’attuale repubblica moldava si sono intersecati due progetti politici in costante competizione fra loro: quello nazionale rumeno e quello imperiale russo-sovietico. Credo che in questo senso sia molto d’aiuto richiamarsi a Miroslav Hroch per comprendere alcune delle complicazioni che si agitano nell’identità moldava. Secondo lo storico e teorico politico ceco la costruzione di una comunità nazionale avviene in tre stadi: la scoperta o l’invenzione delle proprie origini (l’etnogenesi del popolo), la nazionalizzazione delle élite con la conseguente canonizzazione della storia e la creazione di un pantheon condiviso di eroi, infine la nazionalizzazione delle masse (secondo lo storico Eugen Weber questo avveniva con “la scuola e le strade”, con l’eduzione generalizzata e con i collegamenti infrastrutturali fra città e campagna).
Ora, è chiaro che nel caso moldavo, soprattutto per quanto riguarda il secondo e il terzo stadio, si è trattato di processi incompleti e in cui si sono verificate continue “interferenze”: le élite e gli intellettuali patriottici moldavi attivi nel periodo interbellico, che poi vennero decimati durante l’epoca sovietica, avevano sostanzialmente accettato una comprensione della storia del popolo moldavo di derivazione rumena ma al tempo stesso erano persone socializzate attraverso la lingua russa e attraverso la mentalità imperiale-zarista. È un po’ una situazione simile a oggi: i moldavi si percepiscono come legati alla Romania ma al tempo stesso sono stati socializzati attraverso elementi linguistici e politici di altra provenienza.
Perciò, io credo che dovremmo avviarci verso una concezione prettamente europea del discorso nazionale incentrata su due elementi principali: una lingua di stato comune, il rumeno, a prescindere dal fatto che le persone si autoidentifichino etnicamente come rumeni, russi, moldavi, ecc., unito al rispetto delle minoranze culturali e linguistiche.
In Moldova già esiste una infrastruttura sociale e istituzionale che garantisce il pluralismo: c’è un alto numero di scuole e asili nido in lingua russa, è facilissimo ottenere documenti ufficiali in russo, ecc. Insomma, penso che la nostra comunità sia al riparo dal nazionalismo esclusivista e anzi credo, e spero, che questa naturale “doppia identità” di fondo (che forse un po’ ci accomuna a regioni come la Transilvania) ci renda in un certo senso più pronti alla società globale.