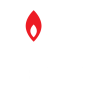(di Lev Rubinštejn, poeta e saggista russo; traduzione di Elda Garetto)
04 maggio 2023
ore 11:07
Nel 2022 la cultura russa è stata chiamata a dare una risposta alla decisione di Vladimir Putin di invadere l’Ucraina. Molti tra quanti si sono espressi contro la guerra sono stati costretti alla clandestinità, mentre coloro che l’hanno approvata sono stati sostenuti dal potere nella loro azione di propaganda dell’odio e delle stragi. Il poeta e saggista Lev Rubinštejn, fondatore del concettualismo moscovita, ha rilasciato il 7 gennaio 2023 un’intervista al giornale on line “Meduza” sulla poesia ai tempi di Buča, sulle forme di resistenza alla repressione, sull’emigrazione, sulla speranza, sulla sopravvivenza di molti meccanismi del sistema sovietico nella politica russa contemporanea, sull’aiuto che può venire a chi protesta contro la guerra dall’esperienza degli artisti underground degli anni ’70 e sulle strategie per affrontare la disperazione per l’orrore dilagante. Ringraziamo la redazione di “Meduza” per aver concesso la pubblicazione della traduzione di Elda Garetto.
Il 24 febbraio ha provocato molti cambiamenti nella vita della società russa. Come ha influito sull’intelligencija creativa?
La definizione di intelligencija creativa non mi piace
per niente: è molto sovietica. Non si tratta di un gruppo omogeneo, ma di molte sfere distinte. Quella cui appartengo è la cultura underground degli anni Settanta; chi si è formato in quel periodo, come artista e come individuo, non ha mutato opinione e orientamento e neppure nel 2022 non si è verificata alcuna spaccatura. L’unica differenza sta nel modo di esprimere il proprio pensiero perché magari non tutti vogliono rischiare guai per colpa delle nuove leggi, che io peraltro considero incostituzionali.
A dicembre abbiamo letto che l’assessore alla cultura di Mosca Aleksandr Kibovskij, meritevole di aver fatto restaurare molti musei e monumenti e dato nuovo impulso alle biblioteche della capitale, aveva esortato a uccidere gli ucraini. Quale influenza ha la cultura secondo lei? Perché il lavoro in quest’ambito non mette al riparo dal rischio di trasformarsi in falchi di guerra?
Non c’è nessuna garanzia in tal senso. La cultura è fragile, come una membrana sottile che si rompe al minimo contatto, non ha armi di difesa né di autosostentamento. Nelle società civilizzate lo stato la sostiene e la rispetta. Se invece si aizza la gente al militarismo in maniera esplicita, dimenticando la cultura, si troverà sempre qualcuno disponibile a fare un pogrom, a cui possono partecipare anche uomini di cultura.
Perché la cultura non garantisce l’evoluzione interiore?
Dipende. La cultura non è universale, agisce in modo diverso sulle persone. Ricordo che ai tempi della perestrojka i rappresentanti della cosiddetta intelligencija creativa la consideravano in maniera utopistica, continuavano a discutere sulle maggiori riviste letterarie, convinti che se avessero pubblicato Solženicyn, Moskva-Petuški di Erofeev, il Dottor Živago o Varlam Šalamov, la Russia sarebbe cambiata. Adesso tutti li leggeranno – si dicevano – resteranno senza fiato e ci sveglieremo in un altro paese. Ma non successe un bel niente: qualcuno li ha letti, altri li hanno ignorati e basta.
Ci sono altri rappresentanti della cultura che la sorprendono per le loro posizioni?
Nessuno in particolare. Per quel che posso vedere, a livello generale, molti sono semplicemente impazziti. Hanno assunto una fraseologia, un’enfasi molto ostile, un linguaggio paranoico. E io ho una lunga esperienza di interazione con i pazzi: nel nostro alloggio in coabitazione avevamo dei folli tra i coinquilini. Una donna, ad esempio, credeva di essere una regina: si era fatta una corona di carta argentata e un mantello di batufoli di cotone al posto dell’ermellino. E allora come adesso, appena succede una piccola cosa iniziano a urlare, ad accapigliarsi, a minacciare di chiamare la polizia o di bruciare tutti.
Crede che ci siano più pazzi adesso rispetto a quando era giovane?
Credo di sì. Questi comportamenti stanno diventando la norma. Certi deputati ci ricordano la situazione descritta da Čechov in Corsia N° 6. Ma oggi non sono possibili né il grottesco, né il sarcasmo, né la parodia – non si può fare una parodia di questa vita. Questo atteggiamento nella Russia contemporaneo è iniziato con Vladimir Žirinovskij. Si dice che una persona raggiunge il massimo grado di rilevanza quando muore. E Žirinovskij, sebbene fosse una persona spregevole, è stato un genio ad esprimere l’inconscio collettivo, a lanciare frasi che molti avevano in mente, ma non osavano pronunciare per decenza. Ora questo è diventato la norma. La maggior parte della Russia attuale è un Žirinovskij collettivo.
Adorno diceva che scrivere poesia dopo Auschwitz è una barbarie, eppure i poeti della seconda metà del Novecento, Lei compreso, lo contraddissero.
Quella di Adorno era una metafora. Ovviamente anche dopo Auschwitz sono stati composti bellissimi versi. E si continuerà a comporli anche dopo il GULAG, dopo i bombardamenti, dopo Buča. Anzi, proprio ora è iniziato un periodo straordinario per la poesia e i versi sono il genere più dinamico e mobile della contemporaneità.
Come sarà la poesia russa dopo Buča, Mariupol’, Cherson?
Non mi appassiono a nessun tipo di previsioni. Aspettiamo che arrivi questo “dopo”, il più presto possibile.
Dopo febbraio è cambiata la poesia nei suoi generi?
Si è molto diversificata. Non indicherei dei generi dominanti, ma sicuramente i migliori sono quelli brevi, e tra questi la poesia su Twitter. Io al momento non scrivo versi, non so perché. Scrivo molti saggi e articoli, che mi sembra importante. Forse come poeta mi sono formato in un altro registro e per l’espressione diretta utilizzo solo la prosa.
Dopo il 24 febbraio in Russia sono state approvate molte leggi repressive, che, ad esempio, hanno vietato termini come “guerra” e qualunque riferimento alle persone LGBT+. In queste condizioni come può scrivere versi chi rimane in Russia?
Con l’esperienza degli anni Settanta posso dire che io e i miei amici, non potendo comunque pubblicare nulla in URSS, scrivevamo quel che volevamo. Ovviamente si rischiava, se non la prigione, il licenziamento, visto che le nostre opere uscivano all’estero in “tamizdat”, come si diceva allora. Per questo molti di noi hanno subito piccole scocciature, come interrogatori della polizia, che era interessata non tanto ai testi, quanto ai contatti con gli stranieri. Ricordando quel periodo posso dare un consiglio semplice: non aver paura. Se si ha paura, allora è meglio lasciar perdere l’arte. Non amo la poesia allegorica, il linguaggio esopico in letteratura è perlopiù limitato. Ricordo che nei primi anni Ottanta uno scrittore aveva mandato un suo romanzo a una rivista. Gli dissero che il libro era buono, che si poteva pubblicare, a patto di eliminare un capitolo. E lui accettò, per “salvare il romanzo”. Secondo me invece l’ha rovinato: non ha salvato l’opera, ma la possibilità di pubblicarla. In Russia l’attività artistica è sempre rischiosa. Per di più l’artista si sente provocato da qualunque atteggiamento proibizionistico o punitivo, e quindi maggiori sono i divieti, maggiore è la volontà di infrangerli.
Negli anni Settanta questo atteggiamento influì sull’espansione della vostra cerchia di rappresentanti dell’arte non ufficiale?
Sicuramente. Per molti miei amici la censura non poteva esistere in assoluto. È una percezione a livello inconscio. Le zone proibite devono essere conquistate dall’artista. Non esiste che ci sia il culo e non la parola per indicarlo.
Ora è comparso un sottogenere specifico, la cosiddetta poesia Z. Che cosa ne pensa?
È rappresentato da persone diverse: ci sono i conformisti, che son sempre esistiti. Nel periodo sovietico pubblicavano versi in occasione delle ricorrenze sotto la guida di Sergej Michalkov. Tra loro c’è anche chi la pensa così sinceramente. Un qualche avvocato del diavolo tra i miei amici disse ad esempio che certo quello scrittore era un bastardo, ma che tuttavia aveva alcune belle poesie. E io risposi che non sapevo che farmene dei suoi bei versi, che avrei saputo scriverne di migliori e che un bastardo rimane un bastardo.
Ma dal punto di vista strettamente artistico cosa ne pensa della poesia Z?
Mi pare che in questo discorso non possa esserci un punto di vista artistico. Da febbraio viviamo in un mondo in bianco e nero, dove tu stai da una parte o dall’altra. Non voglio dire che mi piacciano tutti i versi antimilitaristi, anche lì c’è molta grafomania. Ma la giustifico, perché questi sono i tempi. A me pare che qualunque tendenza filogovernativa sia ipocrita al 100%. Qualcuno dice che vi sia una parte di verità. Non è vero: a partire dall’affermazione che si difende la nostra patria. Ma come si fa a difendere la patria in un altro stato? E da chi la si difende? Sulla tesi che là ci sono “fascisti” e la Nato preferisco non parlare.
Lei è nato nel 1947, dopo la fine della guerra, quando tutti i cittadini sovietici erano uniti nell’idea che non ci dovesse essere una nuova guerra. C’è stato un momento in cui lei ha percepito che quest’idea si è affievolita, sostituita da un’altra convinzione?
Nell’infanzia ero circondato da una gran quantità di persone che avevano combattuto al fronte: praticamente quasi tutti gli uomini adulti, a parte gli anziani, avevano fatto la guerra. Non si usava la parola “veterani” nell’uso contemporaneo, ma “frontoviki” [soldati del fronte, N.d.T.]. L’aver combattuto in guerra non era per loro un merito né un motivo di orgoglio, semplicemente qualcosa che si era abbattuto sulla loro generazione. E se la prendevano con quelli che erano rimasti nelle retrovie, gridando: “ho versato il mio sangue per te, bastardo!”. Quelli del fronte, tra cui anche mio padre, non parlavano volentieri di questo argomento. Invece la stampa, la letteratura, al contrario, ci imbottivano di libri sull’eroismo dei pionieri comunisti. Una lettura terribilmente traumatizzante per la psicologia infantile, con continue descrizioni di torture e fucilazioni. Era tutto abbastanza fasullo e ripetitivo, ma non si riusciva a staccarsene. Ed è per questo che si è inculcato il militarismo nelle giovani generazioni. Io e i miei coetanei desideravano combattere, vincere tutti e fare una bella morte.
Dal 2000 in poi alcuni rappresentanti della sua generazione hanno assunto ruoli decisivi: Vladimir Putin, ad esempio, è del 1952. Magari l’ossessione per la guerra nasce da questa educazione?
Bell’idea. Della serie: non hanno giocato abbastanza. Eppure, la generazione adulta cercava di opporsi a questa ondata di libri e film, perché odiava l’eroicizzazione della guerra. Tutt’intorno c’era una massa tremenda di invalidi – mio padre mi portava ai bagni pubblici e lì non vedevo altro che invalidi senza braccia, gambe, occhi… Nell’aria sembrava di sentire odore di bruciato… I nostri giochi erano gli zaini per le maschere antigas, i binocoli militari, le stellette delle mostrine. Il 9 maggio per molto tempo non è stato una ricorrenza festiva, lo è diventato solo nel 1965, con Brežnev. Dal ventennale in poi iniziò a crescere il culto della guerra. E da allora è iniziata questa mania dei veterani, l’esibizione dei combattenti davanti alle scolaresche, le parate, le fiamme eterne standardizzate, gli obelischi di cemento, le canzoni, le poesie…
Come si spiega?
Ogni generazione di detentori del potere si iscrive al rango di vincitore. È cominciato nel 1965 e dopo El’cin questo tema è stato sempre più sfruttato.
Com’erano i rapporti della popolazione della Repubblica Federata Russa verso gli abitanti dell’Ucraina nel periodo sovietico?
Complessivamente erano buoni, ma con una certa dose d’ironia, come dimostrano le barzellette sugli ucraini, rappresentati in modo folcloristico come dei russi di seconda scelta. Credo che fossero la manifestazione dell’atteggiamento imperialistico, come si dice adesso. Ad esempio, quand’ero bambino c’erano due attori di varietà: Stepsel e Tarapunka. Il loro umorismo era decisamente grossolano, ma io ero un bambino che si divertiva con poco e mi piaceva tutto. L’attrattiva principale consisteva nel fatto che Stepsel parlava un “buon” russo letterario, mentre Tarapunka parlava “suržik” [un misto di russo e ucraino, N.d.T.]. Non c’era odio, semmai un leggero disprezzo che raffigurava gli ucraini da barzelletta come furbetti, stupidotti e ingordi. Una sorta di provincia che parla male russo. E questo succedeva a Kiev, dove la maggioranza della popolazione era russofona, intelligencija compresa e considerava chi parlava ucraino come dei contadini ignoranti.
Che spazio di azione avevano i rappresentanti della cultura di lingua ucraina in un contesto di oppressione dell’identità nazionale?
Erano perseguitati e ce n’erano pochi. Nel 1960, quando i miei amici dissidenti finivano nei campi di reclusione, vi trovavano sempre degli ucraini, che cercavano di difendere l’identità nazionale, scrivevano in ucraino. Invece il potere sovietico voleva forgiare l’Ucraina sovietica, anche se era un raggiro, come lo champagne sovietico. Un ossimoro.
E ha notato quando questo atteggiamento sprezzante, ironico verso gli ucraini è diventato odio?
Molto recentemente. È cominciato col primo Majdan, quando gli ucraini, desiderosi di indipendenza, hanno espresso la volontà di avvicinarsi all’Europa. Nella logica dei dirigenti russi questa “fuga da casa” è imperdonabile, tanto più che l’Ucraina era considerata come un fratello o una sorella minore, “uguale a noi, solo un po’ peggio: più stupida e sventata”.
Questo atteggiamento nei confronti dell’Ucraina in passato le sembrava normale? E adesso cosa pensa? Sarebbe stato possibile cambiare questa visione imperialista?
Onestamente, né io né i miei amici eravamo molto interessati a questo argomento. È sbagliato, certo, ma è la verità, non voglio fingere di aver sempre capito tutto. Certo, qualunque tipo di atteggiamento discriminatorio ci sembrava ripugnante e noi non lo condividevamo. Ma è importante ricordare una cosa: molti di noi pensavano che proprio Kiev e l’Ucraina fossero il baluardo dell’URSS. Infatti, i dirigenti della repubblica ucraina erano i più convinti sostenitori della linea del PCUS. Di conseguenza l’astio nei loro confronti si trasferiva involontariamente a tutta la nazione e alla sua lingua. Confesso con rammarico che anche noi eravamo condizionati da questo atteggiamento imperialistico, anche se non avevamo una mentalità di quel tipo. C’è voluto del tempo e molti sforzi per superare questo condizionamento, anche se i germi di questa mentalità si possono individuare anche nel linguaggio quotidiano: bisogna ricordarlo e contrastarli costantemente.
E lei da ragazzo come considerava gli ucraini?
Sempre con molto interesse: infatti mia madre è nata in Ucraina, è cresciuta a Poltava e poi si è trasferita a Charkiv. Descriveva fatti tremendi, come il holodomor dei primi anni Trenta. Sua sorella maggiore era riuscita a trovar lavoro al pastificio di Charkiv: la pagavano non in denaro ma con i prodotti di lavorazione. Nel periodo più terribile, l’inverno del 1932-33 tutta la nostra famiglia sopravvisse grazie a quei maccheroni. Da allora mia madre non riuscì più a mangiarli. E nella piazza della stazione si vedevano cadaveri, nessuno li portava via: erano contadini che venivano in città per trovare da mangiare, ma una volta arrivati si stendevano per terra e morivano.
In un suo saggio lei ha sottolineato che in epoca sovietica la propaganda non arrivava fino al cospirazionismo che vediamo sulla TV di Stato.
La propaganda sovietica era molto goffa. Era tremendamente noiosa, ma, tutto sommato, caratterizzata da una certa correttezza accademica. Questo dipendeva dal fatto che non si poteva pronunciare una sola parola che non fosse stata approvata da una delle relative sezioni del Comitato Centrale, dove lavoravano esperti di Asia, Africa, Usa e Canada, che correggevano i testi e non lasciavano passare nessun arbitrio. Per questo era tutto “sterilizzato”. Qualunque articolo dei maggiori quotidiani, come la “Pravda” era una glossolalia, un’associazione di parole e frasi prive di senso. Ovviamente io non leggevo molto quelle cose, ma tra i miei amici c’erano degli esperti di decriptaggio che dal tono dell’articolo di fondo riuscivano a comprenderne il significato reale. Ad esempio, leggendo un articolo sulla mietitura, pronosticavano: “vuol dire che fra un po’ rilasceranno gli ebrei”. A volte ci azzeccavano.
Da cosa dipende la svolta dell’attuale propaganda verso il cospirazionismo e la falsificazione?
In URSS c’era un sistema bipartitico: il PCUS e il KGB. Il primo chiaramente mentiva, ma lo faceva dal podio più alto e talvolta perfino con una parvenza di verosimiglianza. La strategia del KGB invece era basata su un bieco cinismo, sulla menzogna costante e sulla vigliaccheria come norma di comportamento professionale. Durante i fatti dell’agosto 1991 verso il KGB ci fu un atteggiamento tollerante, si decise che lo si poteva riformare, che avrebbe trovato una sua collocazione nel sistema democratico. E invece si imboscarono: qualcuno si mise al servizio degli oligarchi, ma di fatto i loro piani erano di accumulare soldi e potere per poi tornare a inserirsi nella vita politica. E alla fine ci sono riusciti: negli anni ’80 hanno liquidato i comunisti, alla fine degli anni ’90 i democratici. Dopo di che la strategia e lo stile del KGB è salita alla ribalta.
Negli anni ’70 i russi già si dividevano tra chi era emigrato e chi era rimasto. Lei sia allora che adesso ha scelto di rimanere. C’erano polemiche allora tra questi due gruppi?
Certamente. Ma allora non c’erano i social media e le discussioni erano limitate ai singoli gruppi e si dibatteva un’unica questione: partire o no. Allora questo verbo si usava senza altre precisazioni, perché se ne comprendeva implicitamente il significato. Lo stesso era per l’uso del verbo “presentare”. Presentare domanda? Sì, domanda di emigrare. Dalla metà degli anni ’70 all’inizio degli ’80 c’erano continui commiati da chi partiva. L’intelligencija si era molto diradata. Anche allora si viveva una sensazione di catastrofe. Le proporzioni non erano simili a quelle odierne, considerando che bisognava superare terribili procedure burocratiche: il tormento infinito degli uffici visti di tutti i livelli; era richiesta persino la liberatoria della biblioteca. La gente vendeva tutto quel che poteva e partiva per sempre. Per chi partiva era fondamentale una giustificazione psicologica e addirittura ideale. Cominciavano così: “Tutti voi che restate continuate a lavorare quotidianamente per il KGB e il potere sovietico. Con le tasse che pagate fabbricano missili”… Io non avevo una posizione ferma, ma alla fine furono decisivi due fattori: il primo, di tipo pratico, familiare: i genitori anziani, che non avrebbero capito e che non volevo amareggiare. Il secondo era la lingua, e dunque la mia professione, che è basata qui. Ritengo che lo scultore debba stare vicino all’argilla.
E anche adesso ha la stessa motivazione?
Sì, parenti anziani e la lingua. E poi allora l’emigrazione aveva una sua vita, erano comparse case editrici estere che pubblicavano anche le nostre cose. Poi verso la fine della perestrojka successe un prodigio: mentre camminavo per uno dei boulevards moscoviti ebbi come un’allucinazione, incontrai un tale che era emigrato da tanto tempo. Per me fu come una resurrezione; infatti, l’emigrazione allora era definitiva e, in quanto tale, simile alla morte. Il commiato era come una cerimonia funebre: lutto e pianti. L’unica differenza era che il defunto beveva con te. E poi di colpo ecco che la gente cominciò a ricomparire, prima uno, poi l’altro…
Speriamo che succeda così anche questa volta. Ma la Russia è ripiombata in un periodo di repressione. Che consigli si sente di dare ai giovani che dissentono dal regime?
Ognuno deve scegliersi un certo livello di resistenza e opposizione. Occorre misurare le proprie forze. È importante avere dei principi, ma bisogna chiedersi che cosa uno è disposto a rischiare prima di farli entrare in azione. Ci sono persone adrenaliniche, che vanno fino in fondo, ad esempio la mia amica Julia Galjamina [linguista, docente universitaria, giornalista, politica di opposizione, arrestata e condannata ripetutamente, N.d.T.] che stimo immensamente. Apprezzo molto Il’ja Jašin [politico d’opposizione attualmente in carcere con una condanna a 8 anni e 6 mesi, N.d.T.] e altri politici come lui.
E cosa si può fare per non farsi prendere dallo sconforto per quanto sta accadendo?
C’è una signora che non bisogna dimenticare, anche se ultimamente ha un pessimo aspetto: si chiama speranza, è racchiusa nella psiche umana e ogni tanto bisogna rivolgersi a lei. Bisogna sperare e fare quel che si riesce in base alle proprie forze. Negli anni Settanta, quando i miei amici ed io iniziammo la nostra attività, intorno a noi c’era l’indescrivibile monotonia della stagnazione. Una depressione di merda. Ma in quello scenario comparvero idee artistiche clamorose. Mi ricordo di quegli anni con gratitudine. C’era uno sdoppiamento: da un lato si aveva la percezione di trovarsi in un ambiente ostile: le strade grigie, le espressioni della gente, i mezzi di trasporto, le code. Ma tu passi per tutte queste situazioni e poi sali nella soffitta di una casa sullo Sretenskij Bul’var, dove aveva lo studio il mio amico Il’ja Kabakov. Entri e ti circonda l’odore allegro dei colori e del solvente, e il padrone di casa ti saluta e ti dice che ha appena finito un nuovo lavoro.
Bisogna cercare quei pochi frammenti di bellezza che ancora rimangono nella nostra vita?
Di bellezza, di piacere, di sapore, bisogna volersi bene, aiutarsi, essere amici.
Forse il suo ottimismo stoico dipende dall’aver già vissuto periodi bui di repressione. Può trarne qualche insegnamento? Che cosa aiuta a mantenere l’umanità?
La storia, compresa quella più recente. Negli ultimi anni dell’URSS io e i miei amici più stretti eravamo convinti che quella melma pesante ci avrebbe circondato in eterno. Eravamo pronti a vivere per sempre in quella merda. Ma successe il contrario. Così come nel diritto esiste il concetto di precedente, lo stesso succede anche nella storia. Quel che è stato possibile una volta può verificarsi nuovamente. Sono convinto che sarà così. L’unica questione è che sono già anziano e non sono certo che farò in tempo.
Ma lei si è già sbagliato una volta a questo proposito…
Anche più di una. Stalin schiattò quando avevo 6 anni e questa rimane per me una bella notizia. Ricordo quel giorno come se fosse ora. Il 1953, una casa in coabitazione. Ho la tonsillite, ma sto già meglio. Nella mia stanza c’è la radio accesa, mia madre è andata in farmacia. Sono molto afflitto perché sono già le 10 del mattino e ancora non è iniziata la trasmissione per i bambini. C’è solo musica noiosa e di tanto in tanto parla Levitan [lo speaker ufficiale della radio sovietica di quel periodo, N.d.T.]. Non capisco niente. Poi arriva mio fratello maggiore da scuola, ha 15 anni e fa la nona classe [il sistema scolastico sovietico accorpava la scuola elementare e media in un unico ciclo, N.d.T.]. E dice: “Tu te ne stai a letto e Stalin è morto”. Io non riuscivo a capire: per un verso a 6 anni l’idea di morte non è molto chiara, dall’altro la radio ripeteva in continuazione che lui è immortale. La radio diceva anche che Stalin è il padre e anche qui si creava uno sdoppiamento di coscienza: risultava che avevo due padri e uno di loro era morto..
Due padri con le leggi attuali sono già un capo d’imputazione…
Sì, certo, ma c’era anche una madre. Una configurazione complicata. E i vicini in cucina singhiozzano e io non capisco niente. Ma allora ero piccolo. Ma un mio collega, un po’ più vecchio, nel ricordare quel giorno raccontava un’altra storia. Aveva 9 o 10 anni, anche lui a Mosca, anche lui in coabitazione. Le donne in cucina urlano e piangono. E lui, annoiato, gira per il corridoio. E apre la porta di una stanza dove di solito entrava senza bussare: ci abitavano due sorelle di una cinquantina d’anni che gli erano affezionate e gli lasciavano sfogliare gli album di fotografie. Erano delle “sopravvissute” e avevano molti oggetti di prima della rivoluzione. Lui entra e rimane impietrito sulla soglia nel vedere una scena stranissima: le due sorelle in silenzio ballano il valzer in mezzo alla stanza. Festeggiano. Poi apprese che il marito di una era stato fucilato e il figlio dell’altra era morto in un lager.
Passiamo da Stalin a un periodo posteriore. L’inizio della sua attività artistica coincise con gli anni della stagnazione. Pensa che si possano paragonare gli ultimi anni con quel periodo?
Penso di no. Tutte le epoche storiche suggeriscono delle associazioni, delle rime. Ma la rima non è ripetizione, ma assonanza. Occorre tenerlo presente. E anche qui non c’è una totale somiglianza: c’è qualcosa di simile nell’atmosfera di chiusura senza sbocchi.
Si può trovare un’assonanza tra la retorica “Z” e qualcuna delle ideologie sovietiche?
In parte con gli anni Trenta staliniani, ma allora almeno c’era qualche forma di entusiasmo, mentre adesso non c’è, solo isteria disperata, il culto della morte e della sconfitta. Anche la poesia Z è ispirata dalla paura e dalla mancanza di fede. Tanto più che l’idea del futuro come categoria è assente da circa un ventennio dai discorsi ufficiali. Il futuro non esiste. Per questo sono così agguerriti nell’affermare la propria versione storica.