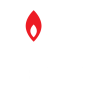Pubblichiamo qui la trascrizione della prima testimonianza realizzata per il progetto “Voci dalla guerra”. Il video dell’intervista coi sottotitoli in italiano a cura delle traduttrici Luisa Doplicher, Sara Polidoro e Claudia Zonghetti, è disponibile nel canale YouTube di Memorial Italia a questo link.
23.07.2022
Denys Volocha
La trentunenne Hanna Ševčyk lavorava nella maternità di Mariupol’. La guerra l’ha costretta a trascorrere un mese in un rifugio antiaereo sotto una fabbrica di dolciumi. Rispetto ad altre storie sulla vita in guerra, la sua è piena di dettagli medici e chiarisce quali problemi insorgono se si vive stabilmente in un rifugio antiaereo, e come si curano i malati quando le medicine e l’attrezzatura scarseggiano.
Che cosa significa essere un medico in un rifugio antiaereo?
“È stato chiaro da subito che ero l’unico medico nel rifugio antiaereo. Quindi ero preziosissima. Mi chiamavano di continuo. Per qualunque cosa.” – inizia il suo racconto la dottoressa Ševčyk. Ecco che cosa racconta dopo.
Ho chiesto agli uomini di andare a cercare le medicine. Hanno trovato quelle rimaste nelle farmacie distrutte. A volte ce le portavano i nostri soldati, gli ucraini, ed è stato un grosso aiuto. Ho messo su un armadietto di fortuna con i medicinali, dividendoli in gruppi, per poter curare la gente. Tempo dopo mi hanno portato uno stetoscopio e uno sfigmomanometro. Era roba da poco, ma sempre meglio di niente. A un certo punto la gente ha iniziato a star male sul serio. Parecchio, e tutti quanti.
Una donna ha avuto una crisi ipertensiva, ho dovuto farle una flebo lì, nel rifugio. L’attrezzatura ce l’avevo, per fortuna, e anche il magnesio. Poi è arrivata un’infezione intestinale. Il primo a prendersela è stato Egorka, un bimbo di quattro mesi, che ha cominciato con le coliche, e anche vomito e diarrea, e febbre alta. Provavano a curarlo reidratandolo, usando vari metodi. Ma io ho capito che ci volevano gli antibiotici.
Però le infezioni intestinali sono insidiose, qualunque antibiotico per bocca viene rivomitato all’istante. Bambini o adulti che siano. Ne serviva uno iniettabile, ci voleva un’iniezione. Il problema successivo è stato che l’antibiotico da iniettare c’era, ma mancavano le siringhe. C’erano quelle da 10 cc, ma quelle da 2 cc erano pochissime. Però, siccome a un certo punto hanno iniziato a star male tutti, e i sintomi erano sempre gli stessi, con una debolezza spaventosa, le iniezioni servivano come il pane e ho dovuto trovare il modo di sterilizzare le siringhe. Quelle usa e getta, dico. In pratica le sciacquavo con l’acqua che c’era, con quella che trovavamo, acqua piovana o neve sciolta che fosse. E ci versavamo sopra la vodka per sterilizzarle in qualche modo e poter curare la gente.
C’era un bambino autistico. Aveva attacchi di tipo epilettico, cioè degli accessi convulsivi. E noi non avevamo medicine per curarlo. Si è preso anche lui l’infezione intestinale, ma grazie al cielo l’ha superata ed è guarito. Il bimbo di quattro mesi aveva genitori ansiosi, che volevano vederlo guarire subito. Chiaramente il piccolo era molto debole, faceva parecchi capricci. Vicino avevamo l’ospedale n. 3, con la pediatria e la maternità: ormai lo conoscono tutti. [Il 9 marzo lo colpì una bomba russa].
Ho consigliato di portarlo lì; magari gli facevano una flebo e lo tenevano sotto osservazione. Gli aghi che avevo io erano troppo grandi per fare un’iniezione a un bimbo così piccolo e curarlo in quel modo. Alla fine il papà si è deciso: “Va bene, Anja, ci andiamo. Troviamo una macchina, sentiamo i medici e torniamo qua”. Il giorno dopo l’ospedale è stato bombardato. C’è andata di mezzo parecchia gente, lo sanno tutti. La maternità è andata distrutta, e anche il reparto pediatrico di malattie somatiche. “Santo cielo”, mi sono detta allora, “li ho mandati a morire”. Mi è preso un colpo perché volevo bene a tutti, nel rifugio antiaereo. Li conoscevo tutti quanti, conoscevo le loro famiglie, sapevo cosa gli era successo e dove abitavano, addirittura in quale casa. Per non parlare del resto.
Grazie al cielo erano sopravvissuti, stavano bene. E sono tornati da noi. A piedi. Ira, la mamma di Egorka, è arrivata ed è svenuta, e io ho cercato di farla rinvenire con “l’ammoniaca”. Quando ha aperto gli occhi, la sua prima frase è stata:
“Anja, ma tu le hai mai viste delle donne incinte senza gambe né braccia? È una cosa che non ci si può immaginare. C’erano cadaveri di bambini ovunque… Era spaventoso”.
Non so più che volta è che ripenso a queste cose, eppure mi viene sempre da piangere, è più forte di me [si asciuga le lacrime con il fazzoletto].
Poi si sono ammalati i più grandicelli, un bambino di un anno e mezzo. Anche a lui ho dovuto fare le iniezioni, perché non si riprendeva e la febbre non andava giù, era già trascorsa una settimana e niente, non passava. Ho trovato un po’ di Novalgina e di Medrol, l’unica fiala che avevo, e gliel’ho iniettata a mio rischio e pericolo. La febbre è scesa, ma il giorno dopo è venuta alta a mio figlio. E l’indomani a mio nipote. Insomma, mi sono resa conto che salvavo ogni bambino a danno di un altro. E quando dovevo far scendere la febbre a mio figlio, non avevo più farmaci. Pazienza, mi sono detta. È la guerra, devi risolvere i problemi con quello che hai. Meno male che avevamo ancora gli antibiotici. Per fortuna avevo riempito uno zaino con tutte le medicine che avevo in casa, e con quelle che ero riuscita a comprare dopo in farmacia. Così ho potuto curare i “miei” bambini, cioè mio nipote e mio figlio, e anche gli altri.
A un certo punto hanno cominciato a star male gli adulti. Hanno cominciato a scarseggiare le medicine, e ho dovuto decidere a chi potevo darle. Anzi peggio: a chi darle e a chi no. Ho deciso da sola che, come sempre capita in guerra, le avrei usate per i giovani e i bambini, e non per gli anziani. O non sarebbero bastate per i giovani.
E la gente ha iniziato a morire. In un solo giorno sono morti due uomini. Due anziani. Uno era senza un braccio; l’altro era semplicemente vecchio. Erano soli. Senza nessuno. I parenti non li avevano, o chissà dove stavano. Non raccontavano mai nulla, erano taciturni.
C’erano forti bombardamenti, intorno a noi, bruciava tutto: era bruciato il mercato centrale, completamente, e anche tutti i negozi vicino. Avevano centrato anche la fabbrica, che non aveva più le finestre, e anche altro. Insomma, non c’era modo di seppellirli. Così li hanno portati fuori, li hanno lasciati un po’ lontano, e lì è finita. Scavare una buca era impossibile.
Poi abbiamo saputo che la casa di alcuni amici aveva subito gravi danni nei bombardamenti. Era stata colpita ed era bruciato tutto. Mio fratello ha chiesto a certi conoscenti di andarli a prendere in macchina. Li hanno portati tutti qui. Erano due famiglie: quella di Alina, con marito e figlio, e quella di sua sorella Lera, con il marito Leša e il figlioletto. E la nonna Ljubov’: hanno portato anche lei. Quello stesso giorno Lera mi ha chiesto: “Аnja, fammi il favore, dalle un’occhiata, dice che le fa male il piede”. Ho risposto: “Va bene, vediamo un po’”. Ho visto che sul tallone di Ljubov’ si era formata un’ulcera diabetica piuttosto grossa.
Aveva una grande piaga poco irrorata, e la pressione altissima. Stava male, quasi non camminava. Ho iniziato a chiedere, mi sono fatta dire tutto. Come mai non se n’erano mai accorti? E lì mi ha detto che aveva avuto il covid ed era stata ricoverata a lungo. Aveva il diabete mellito, l’ipertensione e altre comorbidità…
L’unica cosa che potevo proporre era rimuovere dal tallone il tessuto necrotizzato per rallentare un po’ il processo. Ma ho detto ai parenti che, nelle condizioni in cui ci trovavamo, dovevano prepararsi al peggio: poteva anche non farcela. Ho rimosso il tessuto necrotizzato. Ljubov’ si è sentita un po’ meglio. Ma dall’indomani è peggiorata via via. Era sempre più debole. L’abbiamo fatta stendere, le abbiamo messo attorno una tendina improvvisata, fatta con della stoffa che abbiamo trovato, con le lenzuola. Ogni tanto andavo da lei, per vedere come stava. Ho detto alle figlie, Lera e Alina, che potevo darle un analgesico, ne avevo alcuni piuttosto forti di scorta. Ma ho spiegato che non sarebbe stata una cosa continuativa, o non sarebbero bastati per gli altri. E che prima o poi Ljubov’ se ne sarebbe andata. Le ho fatto un’iniezione di analgesico. Si è sentita meglio, la notte ha dormito bene. Poi i militari mi hanno procurato del Voltaren in fiale, e le ho iniettato anche quello.
Alina mi ha detto che di notte avrebbe fatto lei le iniezioni, per non svegliarmi. Dormivo male, la notte, perché mi svegliavano di continuo. In realtà è meglio così. In questo modo ho superato più facilmente vari momenti, perché la mia presenza era utile e importante. Succedeva tutto così in fretta, non c’era tempo di tirare il fiato e piangersi addosso. Compativi gli altri, e questo era di conforto, almeno un po’.
Dopo una decina di giorni Ljubov’ ha iniziato a stare malissimo. Ho detto alle figlie che potevo farle una flebo per tenerla in vita ancora un po’, ma aveva senso, sapendo che se ne sarebbe andata comunque? Avremmo consumato medicine che potevano servire ai feriti che arrivavano e che, magari, si potevano salvare. Lera e Alina hanno risposto che erano d’accordo con me e capivano perfettamente. Abbiamo deciso di aspettare e basta. Dopo una decina di giorni Lera mi ha chiesto di controllare se la madre respirava ancora. Sono rimasta un po’ con lei. E a un certo punto se n’è andata.
Quando è mancata, abbiamo rispettato le usanze, e le abbiamo legato le mani e la mandibola. Le figlie chiedevano a me cosa bisognava fare e come. Io non sono esperta, ma sapevo queste cose perché poco tempo prima c’era stato il funerale di mia nonna. E ho chiesto un grande favore agli uomini del rifugio: se la mattina seguente fosse stata calma, gli ho chiesto di scavare una fossa, perché era mancata la mamma di amici. Ci sono riusciti. Alina e Lera hanno salutato la mamma, e l’abbiamo sepolta vicino al rifugio. Abbiamo anche trovato un libro di preghiere, hanno letto qualcosa.
Ho avuto anche due donne incinte, una alla 34° e una alla 36° settimana. Una si è presa una forte intossicazione: sempre un’infezione intestinale, con la febbre a 42° C che non voleva saperne di scendere. Temevo che le iniziassero le doglie, che partorisse nel rifugio. Io sono pediatra e neonatologa, ho studiato e so molte cose, ma non avevo mai assistito una partoriente. Non avevo ancora esperienze in quel campo. Temevo che succedesse qualcosa senza che avessi il necessario. C’era un ragazzo, un volontario. L’ho pregato di chiedere ai militari se potevano procurarci qualche ferro chirurgico. Materiale per suture, ago, pinza chirurgica.
Ho chiesto pannolini, ossitocina, emostatici, tutto quello che poteva servire per aiutare le due ragazze. Grazie al cielo sono guarite: l’intossicazione è passata, la febbre è scesa. Poi sono venuti i mariti con un altro ragazzo per portarle via. Non ho mai saputo se sono arrivati a destinazione sani e salvi, se sono riusciti a lasciare la città. Sono cose che si fanno a proprio rischio e pericolo.
Noi non avevamo l’automobile. Sapevamo che saremmo rimasti a lungo nel rifugio. Ci abbiamo trascorso un mese. Ogni volta che andava via qualcuno e restavamo in meno persone, ci si spaventava. Resto qui, mi dicevo, e neanche so quanto durerà questa storia. Magari non basterà il cibo e neanche l’acqua, chissà se avremmo potuto raccogliere un po’ di pioggia, e così via.
Poi sono arrivati i russi
Quando c’erano i nostri, gli ucraini, si stava un po’ più tranquilli, i nostri soldati ci avrebbero difeso e sarebbe andato tutto bene. Poi sono arrivati i russi che hanno raso al suolo il teatro. Anche lì c’era moltissima gente: più di 800 persone. Prima, con il negozio ancora in funzione, una buona metà veniva da noi in cerca di cibo. Poi, col teatro distrutto e i tanti morti, alcune persone sono venute da noi, nel nostro rifugio, nel seminterrato accanto al nostro. Era una scena spaventosa. Ci avevamo fatto un po’ l’abitudine, prima, agli spari. Ma non c’erano mai stati tanti feriti e tanto dolore. Loro ne avevano viste tante, di scene strazianti. Sono arrivati con i feriti. E io li visitavo tutti, certo.
Una donna si era salvata grazie al giubbotto che portava, un piumino nero piuttosto spesso. Un frammento di bomba si era conficcato nel dietro del piumino; un altro le si era conficcato nella colonna vertebrale. “Ci ha visitato un ufficiale medico”, mi ha detto, “e ha confermato che non sono rimaste schegge”. Ho dato uno sguardo: c’era una ferita da cui colava il pus. Gliel’ho medicata e ho iniziato a palparla, a toccarla con la mano. “In realtà”, le ho detto, “hai un frammento nella schiena”. E lei: “Ma no, il medico ha detto di no”. E io: “L’avrà anche detto, ma il frammento c’è”. “Che cosa devo fare?”, mi ha chiesto. “Muoverti il meno possibile. Se il frammento si sposta, toglierlo diventa impossibile, perché può fare qualche danno e rimani paralizzata. Quindi devi semplicemente restare stesa e sperare che l’organismo lo accetti, lo ricopra di tessuto connettivo e si richiuda. L’importante è medicare sempre la ferita”.
Tutto si è rimarginato benissimo. Poi il marito ha trovato un metal detector, e passandolo sulla schiena della moglie ha rilevato il frammento. Insomma, sì, gli ufficiali medici niente… A capire che c’era qualcosa è stata una pediatra trentenne.