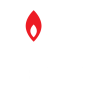(di Katia Margolis)
19 dicembre 2022
ore 09:15
Riproponiamo qui in traduzione italiana la riflessione dell’artista russa stabilitasi 18 anni fa a Venezia Katia Margolis, di Memorial Italia. Continuiamo così la pubblicazione di testi che ci sembrano rilevanti per il dibattito fra gli intellettuali russi sul rapporto tra cultura e potere. Consultabile nella versione inglese e francese.
Nel suo recente saggio Don’t blame Dostoevsky, uscito lo scorso luglio su “The Atlantic” (un articolo dello stesso autore in cui sono esposte tesi identiche è stato tradotto per il sito di Memorial Italia da Emanuela Bonacorsi, N.d.R.) Mikhail Shishkin contesta la cancel culture antirussa che ha fatto rapidamente seguito alla guerra in corso. Per Shishkin, il meglio della letteratura russa è un appello alla giustizia e all’umanità e, piuttosto che essere la narrazione di potere che molti vorrebbero, è stata di frequente vittima a sua volta di persecuzioni e censure. Shishkin rifiuta con forza l’idea che la letteratura sia in qualche modo responsabile dell’imperialismo russo e delle atrocità della guerra di questi mesi; come modelli ideali – per quanto inefficaci, alla fine dei conti – di come l’intelligencija letteraria potrebbe reagire alla persecuzione o alla paralisi sociale cita due testi classici: Di chi è la colpa? di Aleksandr Herzen e Che fare? di Nikolaj Černyševskij. A emblema della paura, dell’apatia e dell’ignoranza che nei secoli e nel susseguirsi di regimi brutali e oppressivi hanno impedito ai russi di prendere in mano il proprio destino elegge, invece, un passaggio dai versi conclusivi del Boris Godunov di Puškin: “Narod bezmolvstvuet” (“Il popolo rimane in silenzio”).
“La storia della cultura russa”, rileva ancora Shishkin, “è una storia di resistenza disperata e non priva di sconfitte schiaccianti contro un potere statale criminale”, da cui lo scrittore russo deduce che la cultura non può che essere “l’unica […] via d’uscita da questo circolo vizioso”. Solo la letteratura, afferma Shishkin, può colmare il divario tra l’ignoranza barbarica e l’umanesimo “civilizzato”.
Sebbene una resistenza che non sfoci direttamente nella vittoria sia sicuramente degna e non priva di un suo intrinseco valore, la proposta di Shishkin non può che suscitare ulteriori domande sulla via da seguire – eventualmente – per incoraggiare quel rinnovamento culturale e, soprattutto, umano in cui speriamo tutti.
Per nostra sfortuna, la storia culturale e sociale della Russia segue una strada contraria rispetto a quella tracciata da Shishkin. Nonostante i bagliori di un retaggio culturale edificante e una storia turbolenta con insegnamenti di facile lettura, molti russi hanno imparato poco o nulla dal loro passato e persistono nello stesso percorso di autodistruzione, vecchio di secoli. Prim’ancora di guardare alla letteratura o alle arti quali mezzi validi di salvezza, dobbiamo prima capire qualcosa su noi stessi. Il filosofo inglese John Stuart Mill ha detto che la tirannia che la società esercita su sé stessa è maggiore rispetto a quelle che il singolo individuo può esercitare sulla società. Se servisse un esempio contemporaneo per ribadire l’assunto, la Russia moderna sarebbe la scelta perfetta.
Molti di noi, Shishkin compreso, sono a volte tentati di fare dei russi le vittime impotenti e fataliste di una forza malefica molto più grande di loro. È, questa, una visione passiva e auto-alimentata dello spirito russo; è istintiva, ed è un comodo schermo dietro al quale nascondersi. Ma è una posizione pericolosa e controproducente, una scappatoia troppo semplicistica che usa il vittimismo per assolverci dall’autocritica, e che eleva tale assoluzione a tratto peculiare della nostra cultura e del nostro canone letterario.
L’idea che i russi siano capaci di autocritica quale conseguenza spontanea dell’immersione nel loro sontuoso patrimonio letterario può essere perdonata solo a chi russo non è. Nonostante i suoi appassionati appelli all’umanità e alla misericordia – da Puškin a Dostoevskij, da Gogol’ a Čechov, da Tolstoj a Solženicyn – la letteratura russa ha avuto, in realtà, un impatto trascurabile sulla presa di coscienza sociale e umanitaria dei russi. Francamente, un certo qual orgoglio romantico per le rappresentazioni letterarie della tormentata “anima russa” è inevitabile, ma è raro che le disgrazie reali o fittizie della letteratura russa siano state viste come qualcosa di diverso da semplici exploit letterari.
La cultura russa classica – e quella letteraria in particolare – è come congelata in una sorta di museo (o mausoleo) che, pur fonte di un vago “orgoglio nazionale”, si fa prodotto per il consumo locale o brand per l’esportazione, oppure materia prima per visite guidate di turisti o scolaresche. Non ha mai avuto il potere metamorfico che molti di noi, Shishkin compreso, si aspettavano o desideravano che avesse. Perché dovrebbe ritrovarselo ora?
Una dimostrazione di cosa si celi dietro l’intransigenza e l’ostinazione – fatali entrambe – dei miei connazionali l’ho avuta inesorabilmente dal modo in cui è stato accolto un mio recente articolo pubblicato su “Novaja Gazeta Europe” in cui analizzo la celebre poesia di Iosif Brodskij “Sull’indipendenza dell’Ucraina” (1991) e le idee imperialiste e anti-ucraine che vi sono esposte. Le reazioni al mio articolo, più che l’articolo stesso, saranno l’argomento principale di questo scritto; per i non russi che non conoscono il testo a cui faccio riferimento, ne offro qui una breve sintesi.
Delle velenose dieci quartine della poesia di Brodskij, Artëm Serebrennikov ha dato un’eccellente traduzione inglese “simil rap”. In questo “anti-viatico” per l’Ucraina da poco indipendente dopo il crollo della Russia sovietica del 1991, gli stereotipi si sprecano: l’enfatizzazione del collaborazionismo ucraino-nazista, le acconciature dei cosacchi, il boršč dolciastro; tutto viene messo in puntuto, doloroso risalto. I versi conclusivi, poi, danno un’idea chiara della posizione di Brodskij nei confronti dell’Ucraina in quel particolare momento storico: “Dio v’assista, guardiani di lager, atamani e stirpe cosacca. / Perché di certo se di morire vi tocca, / aggrappati al materasso reciterete rantolando / non le stronzate di Taras, ma i versi di Alessandro” [Taras Ševčenko e Aleksandr Puškin. N.d.T.]
Se il bersaglio dell’invettiva fossero stati gli ebrei o i neri, invece che gli ucraini, tutti sarebbero insorti. Altrettanto difficile è resistere a un paragone tra la diatriba anti-ucraina di Brodskij e l’antisemitismo di Ezra Pound, soprattutto dato il disprezzo che il poeta russo ha sempre mostrato e dichiarato per le opinioni dello scrittore americano.
Vista, però, l’inattaccabile reputazione di anticonformista di cui gode Brodskij e l’aura quasi sacra di cui lo cingono i suoi estimatori, la mia critica della poesia – con cui volevo invitare a una sacrosanta rivalutazione della nostra cultura e a una sua decolonizzazione da tempo attesa – è stata accolta con sdegno da un ampio spettro di lettori russi, che hanno con ciò tradito una certa incapacità a una pur elementare analisi del loro retaggio culturale, se non di sé stessi.
Classificare il ventaglio di reazioni al mio articolo è un esercizio utile a fornire un quadro chiaro del tipo di risposte che ci si può ragionevolmente attendere quando si esortano i russi a riconsiderare un determinato argomento. Dato che tutti celebrano la genialità creativa di Brodskij, la prevedibilità delle argomentazioni dei miei detrattori risulta a dir poco comica, oltre che deprimente. Ci sono stati i liberali con i loro: “Siamo contro ogni forma di censura” e “Rieccoci ai tempi del Komsomol e delle purghe comuniste!”; i romantici con: “L’arte è libera!”; i patrioti hanno urlato: “Lasciate in pace il nostro eroe nazionale!” e i nazionalisti: “Brodskij era ebreo e aveva in mente Babij jar e il collaborazionismo ucraino nella Seconda Guerra Mondiale!”.
Non mi sono fatta mancare nemmeno gli attacchi ad personam, il solito sparare al messaggero invece di leggere il messaggio. Non posso nemmeno evitare di menzionare la reazione degli “studiosi”. A un livello puramente accademico (molti dei miei detrattori sembrano avere un bagaglio impressionante di qualifiche), costoro sembrano non ammettere due verità fondamentali in ambito letterario, verità talmente ovvie che è quasi imbarazzante ricordarle, una volta finito il liceo. La prima: il fatto che un autore russo possa essere stato censurato o vittima di repressioni come fu Brodskij non lo rende automaticamente un faro di tolleranza o multiculturalismo. La seconda: un autore può essere un “genio” riconosciuto, ma non per questo è esente dall’abboccare ai pregiudizi più oscuri del suo periodo storico e della sua cultura, vale a dire: sciovinismo, antisemitismo, imperialismo e via dicendo.
La discussione avrebbe potuto focalizzarsi su altro, e cioè ci si sarebbe potuti chiedere se lo sfogo di Brodskij fosse un virtuosismo linguistico “ironico” (e se sì, fino a che punto) o una polemica reale, ma le reazioni sono state altre e intempestive; la dicono, comunque, lunga, credo, su quanto accade in Russia oggi.
Ai non russi, opinioni così ingenue e inflessibili, soprattutto tra gli “intellettuali”, possono sembrare poco verosimili. Quanto è successo rappresenta, piuttosto, la conferma di una generale maldisposizione all’autoanalisi, allo sguardo critico su di sé e a un cambiamento individuale e culturale. Il passo, dal rifiuto di riconsiderare un’icona della letteratura – o meglio un singolo suo testo e quanto sottende – al rifiuto di ripensare la forma mentis della propria cultura nel suo complesso, è breve e fatale. L’idea che rimettersi in discussione possa risultare utile è percepita come un pericolo e una minaccia. E il rifiuto di fare questo sforzo è accuratamente dissimulato (probabilmente in modo inconscio, in molti casi) dietro a frasi e argomenti più o meno anodini del tipo di quelli già citati. Naturalmente, un dibattito che si concentri su romanzieri e poeti dell’Otto e Novecento potrebbe essere un diversivo poco utile e persino caldeggiato dal regime. Piuttosto, dovremmo assumerci la responsabilità collettiva della barbarie dell’epoca, della brutalizzazione della nostra società e, più di recente, della carneficina terribile provocata dalla guerra in Ucraina. Che cosa ci impedisce di farlo?
Una risposta convincente si potrebbe trovare in uno slogan ricorrente di Putin – “Non abbandoneremo mai il nostro popolo!” – sventuratamente gradito tanto agli intellettuali russi quanto ai patrioti più convinti, e capace di unire paradossalmente i putinisti ufficiali e i dissidenti anti-Putin, facendo leva con maestria sugli altissimi livelli di paranoia che conseguono a una qualsiasi minaccia (reale o percepita) alla cultura e all’identità russe. Non sorprende che le autorità ne usino e abusino a loro piacimento, esasperando presunti e spesso immaginari casi di “cancellazione” della cultura russa in tutto il mondo a seguito dell’invasione dell’Ucraina. Quello che è un trauma profondamente radicato nella psiche russa fornisce, con ciò, alle autorità uno strumento di manipolazione prezioso per rafforzare l’“unità” e l’“orgoglio nazionale”, oltre che sé stessi e la gerarchia. Con nuovi (e falsi) puntelli a queste fondamenta, il passo successivo sarà giustificare e normalizzare la guerra in Ucraina.
La conseguenza è che la guerra si è insinuata nel profondo di ogni aspetto della vita russa; con un programma sempre più draconiano di repressioni statali, la libertà – e la capacità – di espressione, autoanalisi, prospettiva globale e percezione si è praticamente estinta. Ogni tentativo di discutere questioni complesse o controverse si traduce in posizioni rigidissime e attacchi verbali. Qualsiasi forma di critica letteraria, artistica o sociale è vista attraverso un prisma binario micidiale: “noi” contro “loro”. Qualsiasi forma di indagine obiettiva viene subito bollata come ostile o traditrice, e “tradimento” è di fatto una parola che ricorre spesso in questa triste arena polarizzata. Il sostegno appassionato e “incondizionato” al proprio “popolo” è un istinto fisiologico quasi ferino: un comportamento ricorrente e disumano che si riscontra soprattutto nelle comunità chiuse, nelle sette religiose, nei campi di prigionia e nei paesi in guerra. Allo stesso modo, la nostra psiche di russi evoca a volte niente meno che un gigantesco Gulag di cui saremmo tutti prigionieri in eterno. Un’immagine che varrebbe da sola uno studio approfondito e che, di nuovo, è direttamente ascrivibile alla nostra mancata capacità di autoanalisi, al nostro sottometterci sconsideratamente a un destino fosco che, a volte, viene imposto direttamente dai più alti livelli dello Stato.
Per quanto riguarda la reazione della gente alla guerra, una componente della mentalità russa – che i non russi possono faticare a comprendere – è il valore risibile che viene attribuito alla vita umana (rimasto stabile nei secoli di una storia pur violenta e traumatica) e che contraddice la famosa immagine di Dostoevskij della “lacrima del bambino” (spesso invocata ma mai applicata nella vita reale), vale a dire la riflessione di Ivan Karamazov sull’essenza della compassione. La società russa non conosce nemmeno il livello “base” di solidarietà umana e istinto di sopravvivenza, due qualità che gli occidentali illuminati danno facilmente per scontate.
Quanto detto è risultato particolarmente evidente durante la pandemia. Gli stessi russi che non avevano conosciuto le proteste di massa contro l’oppressione politica, la censura o la violazione dei diritti umani, hanno di colpo combattuto vigorosamente per la loro “libertà” ignorando l’obbligo di indossare la mascherina e rifiutando ogni forma di isolamento e autoisolamento, eccettuato il breve periodo in cui le autorità hanno fatto ricorso al riconoscimento facciale comminando multe salate ai contravventori. Non sono mancate nemmeno le teorie complottiste e, nonostante la diffusione inarrestabile e letale del virus, la gente ha continuato a fare la vita di sempre, ad andare senza riguardo a teatro e al ristorante, snobbando – senza sensibilità alcuna – i tantissimi morti di cui si dava notizia quotidianamente, per non parlare dei propri parenti anziani, di amici e vicini di casa. Come è possibile, tutto questo?
Tanto per cominciare, con alle spalle una lunga serie di catastrofi, molti russi hanno un senso della memoria storica o della continuità molto basso, se non nullo. Personalmente, non posso che pensare alla grande fioritura culturale della Mosca del 1922, quando il mio bisnonno, quel Gustav Špet che aveva fondato l’Istituto di Filosofia dell’Accademia russa delle scienze, rifiutò di andarsene con la celebre “nave dei filosofi” che accompagnava in esilio gli intellettuali non comunisti, e si ritrovò prima esiliato molto più a est e, quindici anni dopo, ucciso in Siberia da quello stesso potere.
Cento anni sembrano non averci insegnato granché.
Di fronte all’incapacità della Russia di guardare alla propria storia per redimersi, si potrebbe pensare che un faro in questa direzione sia rappresentato dalle influenze dall’esterno. Purtroppo, nella Russia moderna i modelli esterni di civiltà vengono imitati solo in superficie e mai assimilati nel profondo. L’esposizione a esempi di pur relativa libertà su Internet – look e stili di vita “europei” e globalizzati, i vantaggi della democrazia e della libertà – riesce a mascherare solo in superficie la miseria e l’ignoranza di gente con una visione arcaica, patriarcale e gerarchica del mondo. Non c’è quindi da stupirsi se imperialismi, colonialismi e sciovinismi di ogni tipo, se la misoginia, l’omofobia e la violenza sono parte talmente integrante della vita russa, da non essere nemmeno percepiti come problemi.
Tra l’altro, lungi dal sabotare la voglia di uno stile di vita “finto borghese”, la guerra in Ucraina l’ha piuttosto intensificata. E non solo perché le autorità hanno ufficialmente bandito dal lessico la parola “guerra”. È, questo, un riflesso della tendenza nazionale a trincerarsi nel fittizio, scambiando per realtà gli orpelli della vita civile. Un po’ come l’adolescente che si convince che certi vestiti o un certo look lo rendono “più cool”, anche la società russa vive un’ossessione tutta infantile per i segni esteriori della vita “normale”: ristoranti e caffè di lusso, festival estivi, vacanze esotiche, vernissage e première sono lo scopo cui bramare sia per la gente comune sia per l’intelligencija. Nell’antica Roma Nerone suonava la cetra mentre Roma bruciava. Nella Russia moderna è la gente a formare l’orchestra.
Il regime è pienamente consapevole di questa mentalità e la alimenta con cura, escogitando utili strategie diversive mentre la guerra infuria. Una di queste è la politica di reclutamento e arruolamento, accuratamente intesa a placare la classe media urbana confortandola nelle sue tendenze imperialiste e colonialiste. Fino alla recente mobilitazione di massa, infatti, più che i “veri” russi (o slavi) erano le minoranze etniche come i buriati, per esempio, a essere inviate al fronte dalla periferia della Federazione. Una tale politica ha contribuito a instillare l’idea confortante che il “lavoro sporco” spetti ad altri, ai veri “cattivi”, e ha sortito il duplice effetto di demonizzare le minoranze etniche “sacrificabili” agli occhi degli ucraini (nel più classico dei divide et impera) e di limitare il numero dei caduti slavi nelle regioni centrali della Federazione in generale e in quelle urbane in particolare, vale a dire là dove le morti e i funerali sarebbero stati quasi impossibili da dissimulare o da evitare. Anche con la coscrizione di massa, tuttavia, a finire in prima linea sono comunque le minoranze etniche, e in numero sproporzionato.
Oltre ai migliori sforzi del regime, a “normalizzare” la guerra contribuiamo anche noi, difendendo e proteggendo la nostra cultura dalla critica e dalla decolonizzazione. Come Maria Antonietta, ne stiamo facendo una brioche elitaria e poco appetitosa piuttosto che un pane da spezzare e di cui nutrirci in modo sano. Se le opere dei grandi artisti del passato e del presente vengono strumentalizzate dal regime per giustificare la sua barbarie, alzare la voce è il nostro dovere di eredi viventi di quegli stessi artisti. Se siamo tentati di compromettere il nostro stesso lavoro nel tentativo – sbagliato – di placare le nostre rispettive comunità di omologhi sociali o intellettuali, a questa tentazione dobbiamo resistere. Se nella letteratura russa del passato o del presente ci sono correnti di sciovinismo e di pregiudizio sgradevoli e avvilenti, è nostro dovere segnalarle e affrontarle per quello che sono. A questo siamo chiamati.
Così come l’antisemitismo non è solo un “problema degli ebrei”, e il razzismo e la misoginia non sono solo problemi delle persone di colore o delle donne, anche il morbo che affligge la cultura in Russia è una nostra responsabilità comune. L’imperialismo e lo sciovinismo della letteratura russa dovrebbero essere una questione di primaria importanza non solo per ucraini, georgiani e estoni, ma anche per noi: scrittori, artisti, intellettuali e lettori russi. L’arte dell’autoanalisi è un’arte che dobbiamo imparare con la massima urgenza, anche se vuol dire ammettere la nostra sconfitta e, pur con grande rammarico, i nostri gravi limiti. Solo così saremo autorizzati a citare le parole che Puškin aveva ripreso a sua volta da Orazio: “Ed in crudele secolo la libertà cantai / E chiesi grazia pei caduti” (A. Puškin, Exegi monumentum, in Poemi e liriche, Torino, 1982, p. 464, trad. Tommaso Landolfi). Dove i caduti siamo noi.