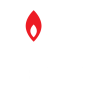(di Irina Ščerbakova)
28 novembre 2022
Aggiornato alle 12:32
Memorial Italia ripropone qui l’introduzione della storica e traduttrice Irina Ščerbakova al volume di Nikolaj Nikulin Memorie di guerra. Leningrado (1941-1945), Milano 2022. Il volume è stato pubblicato nella collana “Narrare la memoria. Le storie dimenticate dell’Europa dell’Est”, si ringrazia l’editore Guerini e Associati per l’autorizzazione a ripubblicare il testo tradotto da Elena Freda Piredda.

Non c’è avvenimento nella storia russa su cui siano stati scritti tanti libri e pubblicate tante memorie quanto la Seconda guerra mondiale. Con l’abolizione della censura, quando dalla fine degli anni Ottanta sono diventate accessibili fonti prima proibite, sono stati in qualche modo riempiti molti vuoti e molte lacune nella storia di questa guerra. Negli anni Duemila si poteva a malapena immaginare che ad attenderci ci sarebbero state nuove scoperte nell’ambito della memorialistica. Tanto più che solo pochi fra coloro che parteciparono effettivamente alla guerra erano ancora in vita. Ma le memorie di Nikolaj Nikulin, pubblicate con una piccola tiratura nel 2008 a sessantatré anni dalla fine della guerra e in un luogo inaspettato, la casa editrice del museo Ermitage, hanno attirato ben presto l’attenzione del pubblico. È divenuto palese che questo testo poteva essere annoverato fra le testimonianze più notevoli lasciate da un ex combattente al fronte.
Prima della pubblicazione di queste memorie, il nome dell’autore era noto soltanto agli storici dell’arte o a coloro che si interessavano di pittura del Rinascimento nordico. Nikolaj Nikolaevič Nikulin era ricercatore capo e membro del Consiglio Scientifico dell’Ermitage, autore di centinaia di articoli, libri e manuali su Bruegel e Bosch, oltre che curatore di molte mostre. E all’improvviso ecco che vengono pubblicate queste memorie impietose nella loro cruda verità, memorie che non soltanto non sono legate alla sua attività di storico dell’arte, ma a prima vista stridono anche con il suo lungo lavoro in uno dei più grandi musei d’arte del mondo.
La biografia di Nikolaj Nikulin è la biografia di un uomo incredibilmente fortunato vissuto nella Russia del XX secolo. Fu fortunato a nascere in una famiglia dell’intelligencija nel 1923, cioè ormai dopo la Guerra civile; fu fortunato a crescere in una delle zone più belle di Leningrado; fu fortunato ad assistere di persona nel 1945, appena tornato dalla guerra, alla riapertura dell’Ermitage, riportato a Leningrado dopo l’evacuazione. Fu fortunato anche in seguito, quando entrò alla Facoltà di Storia dell’Università di Leningrado e studiò con i più grandi esperti dell’arte dell’Europa Occidentale rimasti in vita, fra cui il marito di Anna Achmatova, Nikolaj Punin, poi finito sotto le repressioni staliniane nel 1949. Fu fortunato perché, ancora studente universitario, iniziò a lavorare come guida dell’Ermitage, dove continuò le sue ricerche fino alla fine dei suoi giorni. Ma la fortuna più grande e incredibile fu di essere rimasto in vita nel sanguinoso calderone in cui finì nell’autunno del 1941.
All’inizio della guerra, il 22 giugno 1941, Nikolaj Nikulin aveva appena compiuto diciott’anni e terminato la scuola. Dopo pochi giorni, il 27 giugno, si presentò come volontario nella milizia di Leningrado. Nel novembre 1941 fu mandato fuori Leningrado, sul fronte del Volchov, e partecipò a battaglie durissime presso la stazione di Pogost’e, dove le unità sovietiche più volte tentarono senza speranza di far breccia nella difesa tedesca per spezzare l’assedio di Leningrado. Qui, durante una delle operazioni militari più sanguinose e fallimentari della Seconda guerra mondiale, fra i boschi e le paludi, trovarono la morte centinaia di migliaia di soldati, che furono vittime dei gravissimi errori di calcolo del comando sovietico. «Le battaglie di Pogost’e in qualche misura furono tipiche di tutto il fronte russo-tedesco del 1942. Dappertutto accadde qualcosa di simile, ogni zona – a nord, a sud, vicino a Ržev e vicino a Staraja Russa – ebbe la sua Pogost’e…», scrive Nikulin (p. 47).
In seguito combatté nella fanteria, divenne comandante di un reparto di fucilieri, fu artigliere. Partecipò alla rottura dell’assedio di Leningrado e alle battaglie per conquistare Varsavia e Danzica. Terminò la guerra a Berlino con il grado di sergente. Dal novembre 1941 fino a quando fu ferito per la quarta volta nell’agosto 1944 si trovò sempre in prima linea (con alcuni intervalli nei periodi in cui fu mandato nelle retrovie per guarire dalle ferite riportate).
Chiunque conosca almeno un po’ la storia della difesa di Leningrado e il destino comune che attendeva un soldato semplice, un sergente o un tenente con una biografia militare del genere, capisce che Nikolaj Nikulin non fu soltanto fortunato. Rimanere vivo nei tre anni di guerra in prima linea fu un miracolo incredibile, fu come aver vinto alla lotteria. Per tutta la vita poi questa sensazione e la domanda sul perché fosse sopravvissuto mentre davanti ai suoi occhi erano morti in migliaia perseguitò Nikolaj Nikulin, così come altri combattenti al fronte sopravvissuti nello stesso modo miracoloso. Di quanto le esperienze vissute si ripresentassero continuamente e fossero rimaste come un trauma e una ferita aperta nella memoria per tutto il resto della sua vita, Nikulin scrisse: «Questi appunti sono stati una timida espressione dei pensieri e dei sentimenti che a lungo si sono accumulati nella mia coscienza». E aggiunse anche che era stato il periodo del Disgelo, iniziato dopo la denuncia del culto della personalità di Stalin nel 1956, a spingerlo a scriverle: «In generale questi appunti sono figli del Disgelo degli anni Sessanta, quando la corazza che teneva chiuse le nostre anime ha iniziato a mostrare le prime crepe» (p. 277).
Si tratta di un fenomeno tipico della generazione che definiamo «della guerra». Dieci-quindici anni dopo la fine della guerra, i sopravvissuti che vi avevano partecipato quando avevano fra i diciotto e i venticinque anni avevano fatto in tempo a guarire dalle ferite fisiche, ma allo stesso tempo soffrivano profondamente per le ferite nell’anima. Sono proprio questi uomini, ex soldati e tenenti, che oppongono la loro reale esperienza all’immagine staliniana imbellettata della guerra, sono loro che si riconoscono come i portatori dell’autentica verità sulla guerra. E ne scrivono. Quello che raccontano nelle proprie opere viene definito dai critici «la verità della trincea». Negli anni Sessanta per questa verità sulla guerra ci furono delle vere battaglie ideologiche con gli stalinisti. Non c’è dubbio che Nikulin si sentisse parte del gruppo di testimoni «di trincea» che descrivevano la propria esperienza di guerra. È uno di loro, li unisce un destino militare comune.
Ma Nikulin inizia scrivere queste memorie soltanto nel 1975, dieci anni dopo la fine del Disgelo, nell’epoca della stagnazione brežneviana che ne era seguita:
Una volta, nel tardo autunno del 1975, stavo trascorrendo un periodo di ferie da solo in una cittadina balneare in riva al Mar Baltico. […] E io venni assalito con terribile forza dai ricordi delle esperienze di guerra, tanto insopportabilmente violente che non mi riuscii a trattenere, mi misi a scrivere e in una settimana nacquero queste memorie: il resoconto spontaneo e caotico dei pensieri che mi ossessionavano. […] Scritti non per i lettori, ma per me stesso, sono stati una sorta di emigrazione interiore, una protesta contro la rappresentazione celebrativa della guerra che regnava allora e che continua a esistere ancora adesso (pp. 116-177, 277).
Ciò che spinge Nikulin a raccontare della propria guerra è evidente: disapprova ciò che in quegli anni sta succedendo alla storia e alla memoria della Seconda guerra mondiale.
Proprio la guerra diventa il punto attorno al quale l’ideologia brežneviana tenta di costruire l’immagine di un «noi» collettivo, il popolo sovietico, ma soprattutto di sostituire la storia tragica della guerra con la memoria della vittoria, cacciando in secondo piano la questione del suo costo umano eccessivo. Fino alla Perestrojka nelle fonti ufficiali le cifre reali delle perdite sovietiche – 28 milioni di persone – vengono ridotte di quattro volte. Per quell’epoca ormai non c’è più neanche un famoso generale, per non parlare dei marescialli, che non abbia pubblicato le proprie memorie, dove brandelli di realtà si mischiano a una mitologia aggressiva, che giustifica un modo disumano di condurre la guerra. Gli spietati metodi staliniani del condottiero Žukov, che non risparmiava i suoi soldati, non impediscono che in quegli anni si vada rafforzando l’immagine mitologica del maresciallo «del popolo» (e questo fa infuriare Nikulin, che nei suoi diari include alcuni episodi che rivelano la crudeltà di Žukov).
Il potere in quei quindici anni fa molto per crearsi un appoggio e un sostegno nella figura dei veterani. Gli uomini che davvero sono stati al fronte, che hanno vissuto la tragedia dell’inizio della guerra, i soldati di prima linea come Nikulin in quel momento sono sempre meno, mentre alle posizioni di guida delle associazioni dei veterani arrivano i membri dei reparti politici, della sicurezza di Stato, persone che hanno una memoria della guerra tutta particolare.
Quelli che stanno nelle retrovie rimarranno vivi […], torneranno a casa e con il tempo costituiranno la base delle organizzazioni dei veterani. Gli crescerà la pancia, i capelli si faranno più radi, si appunteranno al petto medaglie al valore e decorazioni e racconteranno di quanto hanno combattuto eroicamente, di come hanno sconfitto Hitler. […] Descriveranno la guerra, di cui loro stessi sanno poco, circondandola di un’aura romantica. […] E il fatto che la guerra è orrore, morte, fame, viltà, viltà, viltà, finirà in secondo piano. E i veri combattenti del fronte, rimasti in due gatti e pure mezzi fuori di testa, ormai distrutti, se ne staranno zitti zitti (p. 157).
In quegli anni tutto il Paese gradualmente viene inondato da modelli di propaganda monumentale che celebrano tutti allo stesso modo la vittoria: le «fiamme eterne» tutte uguali, gli obelischi, gli aridi monumenti, gli impersonali musei della gloria militare. Proprio in quel periodo nascono i complessi pomposi che oggi prevalgono nella memoria della guerra.
Negli anni Settanta si è definito una volta per tutte l’insieme dei cliché che hanno sostituito ed eliminato la memoria viva, mentre il 9 maggio, il giorno della Vittoria, si è gradualmente trasformato in una celebrazione rituale di cordoglio ufficiale, accompagnato da una vuota e rigida retorica e da slogan che si ripetono: «Nessuno è stato dimenticato e niente è stato dimenticato», «Il giorno della Vittoria è una festa con le lacrime agli occhi» ecc.
Questa immagine della guerra come vittoria non poteva che portare, oltre a un nuovo «gelo» politico, a un ritorno di Stalin come principale artefice di questo mito. Per la prima volta dopo l’epoca di Chruščev, Stalin ricompare sugli schermi ritratto come il generalissimo che portò il Paese alla vittoria.
In questo periodo l’immagine di Stalin si associa saldamente alla vittoria, che nella coscienza della maggioranza dei sovietici è l’unico valore immutabile. Proprio allora nascono le formule mitologiche immortali che giustificano Stalin: «Siamo andati incontro alla morte in nome di Stalin», «Se non ci fosse stato Stalin, non avremmo vinto la guerra» ecc. è con tutto questo, con il ruolo di Stalin e con la falsa memoria dei veterani, che Nikolaj Nikulin polemizza continuamente nelle pagine delle sue memorie.
Ci lavorò per molti anni, correggendole e ampliandole. Il libro che uscì un anno e mezzo prima della sua morte contiene le sue memorie (scritte negli anni Settanta), stralci dei diari scritti quando era nell’ospedale militare (nel 1943), alcune novelle in cui è presente una rielaborazione letteraria e le impressioni che trascrisse in un periodo posteriore, generate dagli incontri con i veterani e da un viaggio in Germania (degli anni Ottanta).
Perché gli appunti di Nikulin ci colpiscono così tanto? Innanzitutto perché, con estrema onestà e spirito autocritico, ci dice quanto sia stato difficile scriverli:
Oggi scriverei queste memorie in modo del tutto diverso, senza trattenermi, in modo più impietoso e veritiero, cioè dicendo come sono andate davvero le cose. Nel 1975 la paura rendeva più timida la mia penna. Educato dalla disciplina militare sovietica, che per ogni parola superflua castigava immediatamente, con severità e senza pietà, mi sono autocensurato, in modo cosciente o meno» (p. 277).
Nikulin riesce a ottenere uno stupefacente effetto di straniamento, poiché non abbellisce o eroicizza la propria immagine, come spesso accade nelle memorie di guerra. All’inizio della guerra è un ragazzo distrofico dall’aspetto misero, un soldato che non vale nulla e che fa fatica a rimanere di guardia a trenta gradi sotto zero ogni notte per quattro-sei ore, a scavare la terra gelata, a trascinare i tronchi e le munizioni (la cassa delle munizioni pesa 46 chilogrammi).
Nikulin scrive che la guerra non è solo il fango, la fame, i pidocchi che a centinaia corrono sulla biancheria e sul cappotto. Sfata anche i comuni miti sulla fratellanza dei soldati al fronte, fratellanza che il diciottenne proveniente da una famiglia dell’intelligencija non percepisce in alcun modo. È circondato da estranei che pensano ognuno per sé, non c’è alcuna empatia, soltanto brutalità, durezza e lotta per la sopravvivenza. Scrive anche della crudeltà con la quale viene condotta questa guerra e del totale disprezzo per la vita umana. Simbolo di questo inferno diventa per lui la famigerata stazione di Pogost’e, dove i comandanti continuano a mandare i soldati in attacchi insensati sotto i colpi di mitraglia tedeschi e così, uno sull’altro, cadono nella terra gelata dove si accumulano strati di cadaveri che nessuno riesce a portar via e seppellire.
La guerra di Nikulin non è un’immagine patinata di «imprese eroiche»: l’autore descrive con quanta facilità in queste condizioni siano soffocati i principi del bene, della morale, della giustizia. La guerra, soprattutto, vuole convincere i soldati che la vita umana non vale nulla. È come se Nikulin osservasse il se stesso di allora. Il diciottenne Nikulin viene distrutto e schiacciato, diventa lui stesso una vittima della guerra, si disumanizza, perde i suoi capisaldi morali. Ma questo è un momento di svolta per lui: convinto della sua inevitabile morte, smette di aggrapparsi alla vita per conservarla a qualsiasi costo. Questo (e talvolta i fugaci ricordi di libri, di quadri o dell’Ermitage) lo aiuta a non perdere la propria moralità, a rimanere un uomo in condizioni disumane e, in fondo, a diventare poi quello che sarebbe diventato dopo la guerra.
Nikulin è impietoso nelle sue descrizioni della vita in guerra, infrange dei tabù non detti parlando della difficile sorte delle donne nell’esercito, che vanno costantemente incontro a umiliazioni e insolenze, che vengono importunate e costrette a vivere insieme ai superiori. Scrive anche delle pagine più buie della guerra, cioè delle violenze che i soldati sovietici, attraversato il confine tedesco, compiono nei confronti della popolazione civile, mentre i comandanti non soltanto non pongono un freno, ma anzi sostengono l’ondata di saccheggi e insensata crudeltà:
«Le truppe nel frattempo avevano attraversato il confine con la Germania. Ora la guerra mi mostrò un altro lato inatteso. Mi sembrava di aver fatto esperienza di tutto: la morte, la fame, i bombardamenti, il lavoro estenuante, il freddo. E invece no! C’era ancora qualcosa di terribile, che quasi mi schiacciò» (p. 171).
Nikulin vede distintamente le fonti di questa violenza nell’illegalità e nella crudeltà di cui furono vittime i soldati stessi dell’Armata Rossa. I soldati sovietici combattevano in condizioni difficilissime: erano malnutriti, mal vestiti (e spesso lo rimasero fino alla fine della guerra) e all’inizio della guerra anche male armati. Qualsiasi soldato poteva essere arrestato per la più piccola colpa e fucilato se sospettato di diserzione. Rifiutandosi di entrare nel Partito Comunista senza periodo di prova, come era concesso fare al fronte così da poter mandare più facilmente gli uomini a una morte certa facendo leva sulla coscienza di partito, Nikulin stesso evita soltanto per caso di finire arrestato.
È notevole che nelle descrizioni dei momenti più terribili della guerra si percepisca non soltanto il dono letterario che Nikulin indubbiamente possiede, ma anche uno sguardo da futuro storico dell’arte: è come se descrivesse gli orrori di un quadro di Hieronymus Bosch divenuti realtà. La descrizione degli uomini colpiti dalla cecità notturna dovuta alla distrofia e dei soldati che vagano uno dietro l’altro ricorda La parabola dei ciechi di Bruegel il Vecchio.
Gli appunti di Nikulin si distinguono dalle solite memorie di guerra anche perché l’autore cambia costantemente il «grado di vicinanza» agli avvenimenti descritti, la distanza nel tempo. Non parla soltanto della guerra in sé, ma anche di come viene ricordata, della storia della memoria personale e di tutta la società. Si tratta della riflessione di un uomo intelligente, di un acuto osservatore.
Nikulin riflette sulle difficoltà che incontra ogni tentativo di raccontare la verità sulla guerra. Mentre era in atto, o nei periodi di breve tregua, non se ne parlava quasi: non ve n’era la necessità, perché la guerra comunque circondava tutti e tutto. Quando però finì, la vittoria non portò il conforto che ci si aspettava e parlare di ciò che si era vissuto diventava quasi impossibile anche con i parenti e gli amici più cari, che non avrebbero capito.
Furono davvero in pochi a riuscire a superare le conseguenze di questa guerra e almeno in qualche modo ad analizzare la propria esperienza. La maggior parte degli ex combattenti al fronte continuò a vivere con questi traumi, si diede all’alcool, si autodistrusse, morì per le ferite non soltanto fisiche, ma anche interiori. Si adattarono alla nuova vita a costo di grandi compromessi, accettarono la menzogna e l’ingiustizia della vita in tempo di pace, provando una paura maggiore negli uffici dei propri superiori che al fronte. Come scrisse il poeta Iosif Brodskij nella poesia In morte di Žukov: «entravano audaci nelle capitali altrui, ma tornavano impauriti nella propria…» (I. Brodskij, Na smert’ Žukova in Sočinenija Josifa Brodskogo v šesti tomach, vol. III, Puškinskij fond, Sankt-Peterburg 1998, p. 73). Per questa ragione l’esperienza di guerra che abbiamo ricevuto in eredità, compresa l’esperienza memorialistica, pur nella sua ampiezza, è spesso «tagliata», censurata. Qualcosa si poteva esprimere nelle opere letterarie o in qualche altra forma artistica, ma pubblicare memorie come quelle di Nikulin fu impossibile fino alla Perestrojka. Il fatto stesso che l’autore le abbia scritte in quegli anni è molto importante, anche se, come lui stesso scrive, provava una «paura inestirpabile» e diceva di avere nella testa «un limitatore automatico che non mi permette di superare certi confini» (p. 248).
Alcuni anni dopo la fine della guerra Nikulin di tanto in tanto tornò a visitare i luoghi fuori Leningrado dove aveva combattuto nel 1941-1942. Ogni volta questa visita gli provocava dolore: in quei boschi e in quelle paludi giacevano ancora migliaia di soldati senza sepoltura. L’oblio e l’indifferenza verso quei morti sullo sfondo del cordoglio ufficiale ostentato dallo Stato lo portò a scrivere righe amare, che oggi risuonano non meno attuali di molti anni fa:
L’indifferenza verso la memoria dei morti è il risultato del generale imbarbarimento della nazione. Gli arresti politici durati molti anni, il GULag, la collettivizzazione, la fame non soltanto hanno distrutto milioni di persone, ma hanno anche ucciso la fede nel bene, nella giustizia e nella misericordia. La crudeltà nei confronti del proprio popolo in guerra, i milioni di vittime portate con leggerezza sui campi di battaglia sono fenomeni dello stesso genere. […] La guerra, che è stata condotta con i metodi dei campi di prigionia e della collettivizzazione, non ha portato a uno sviluppo dell’umanità (pp. 263-264).
Pubblicate nel 2008, le memorie di Nikolaj Nikulin hanno fortemente colpito i lettori anche perché sono state accolte nel contesto della politica storica che si è andata formando in quegli anni nella Russia putiniana. Dagli inizi degli anni Duemila, cercando un fondamento ideologico dell’idea nazionale, il potere russo si è rivolto attivamente alla retorica militar-patriottica, usando come simbolo principale l’immagine della Vittoria. Sono state riportate in auge le parate militari, chiamate a dimostrare la potenza dell’armamento russo, sono rinati i peggiori modelli dell’estetica delle celebrazioni di stampo brežneviano: concerti in grande stile, riti sempre uguali ecc.
La viva percezione, rinata nella Perestrojka, del prezzo enorme che si è pagato per la vittoria è stata di nuovo sostituita da vuoti simboli mitologici collettivi, come, per esempio, il cosiddetto «Nastro di San Giorgio» che celebra la vittoria nella Seconda guerra mondiale, che non ha alcuna relazione con la reale memoria della guerra, ma è diventato un simbolo diffuso nella cultura di massa. Questo nastro, che viene legato alle macchine, alle borse ecc., rappresenta una sorta di indulgenza, è un simbolo vuoto che sostituisce una vera riflessione. Perché dovrebbe rappresentare uomini come Nikulin?
Questa politica storica, diventata sempre più militarizzata e nazionalistica, ha comportato anche una rinascita di un elemento importante dell’ideologia sovietica, cioè l’immagine del nemico esterno. La dissoluzione dell’impero e il crollo dell’URSS, la perdita dello status di grande potenza, sono stati definiti la principale catastrofe geopolitica del Ventesimo secolo. È diventata sempre più feroce la propaganda antioccidentale, sono state di volta in volta definite nemiche anche le ex repubbliche sovietiche (i Paesi baltici, la Georgia, l’Ucraina). Sono tornati in vita gli stereotipi della Guerra Fredda e la Russia si è presentata come una fortezza assediata. A partire da questi stereotipi si sono iniziati a riscrivere i manuali scolastici di storia e in misura molto maggiore che nell’epoca brežneviana è ricomparso Stalin, che oggi viene visto dalla maggioranza della popolazione russa come il simbolo della vittoria e non come il creatore e l’organizzatore delle repressioni di massa. L’immagine mitologica e semplificata della guerra come vittoria si è radicata saldamente nella coscienza di massa russa.
Dopo l’annessione della Crimea nel 2014 e le azioni militari nell’Ucraina orientale, la retorica della grande potenza vittoriosa si è enormemente rafforzata e il giorno della Vittoria è stato sfruttato totalmente dal potere per dimostrare il carattere sempre più aggressivo e militaristico della sua politica. La guerra contro l’Ucraina cominciata nel febbraio 2022, nella quale è stata utilizzata con fini propagandistici la retorica antinazista e antifascista, distorce e distrugge la vera memoria della guerra di cui ha scritto Nikulin.
Proprio per questa ragione questo libro oggi ci appare un tragico ammonimento, una risposta a chi oggi detta alla società che cosa si debba pensare e dire della guerra:
«Non c’è monumento o memoriale che possa restituire l’enormità delle perdite in guerra e rendere per davvero immortali le miriadi di inutili vittime. Il miglior modo di fare memoria è dire la verità sulla guerra, raccontare secondo verità quanto è successo» (p. 267).