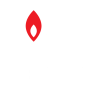(di Massimo Maurizio, professore di Letteratura russa all’Università di Torino, socio di Memorial Italia)
04 luglio 2022
Aggiornato 05 ottobre 2022 alle 13:10
“Chi parla male pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti”, recita una celebre battuta del film Palombella rossa. Le parole sono importanti, e nella propaganda russa di guerra alcune, spogliate di contenuto, hanno rappresentato la giustificazione per l’attacco. E chissà perché c’è bisogno di una giustificazione formale a un atto illogico e assassino, potrebbe sussurrare oggi il nevrotico protagonista del film di Nanni Moretti.
Le parole addotte a giustificazione formale dell’aggressione, come è noto, sono “denazificazione” e “demilitarizzazione”, che, accanto alla taciuta (non a caso) “democrazia”, erano gli slogan dell’Europa post-bellica impegnata nella lotta contro le sacche di resistenza ideologica del nazismo, nonché termini che spesso risuonavano nei processi ai gerarchi tedeschi. Oggi un potere che in maniera palese e dichiarativa ha – negli ultimi 15 anni almeno – chiuso progressivamente sempre più spazi di libertà, si pone come paladino della denazificazione. Un’osservazione di Evgenij Dobrenko su un post nei primi giorni dopo l’occupazione russa dell’Ucraina sottolineava come il termine ‘nazista’ abbia acquisito un significato extra-storico: ‘nazista’ è colui che è contro il corso della storia patria e che viene identificato come nemico, indipendentemente dalla sua ideologia.
Nella dialettica russa di oggi i nazisti non sono i criminali processati a Norimberga, ma i “cattivi” dei film di guerra sovietici, cattivi a tutto tondo, macchiette senza volto che incarnano il male assoluto, immagini prive di qualunque tratto umano. Significati senza significazioni. Simulacri, direbbero i postmodernisti. Il nemico in quanto bersaglio di un odio aprioristicamente giusto, un’avversione che non ha bisogno di argomentazioni, perché sempre e comunque dalla parte della ragione.
Per indicare un atteggiamento antidemocratico o i soldati che combatterono contro l’Unione Sovietica, la lingua russa usa di preferenza la parola fašizm /fašist (fascismo/fascista). Nacist (nazista) ha una connotazione meno universale e proprio per questo viene utilizzato come sostituto di ‘nemico’, ‘alieno’. Alieno alla direzione che ha intrapreso la Federazione Russa, alieno a chi si oppone al progresso, all’apertura, all’accoglienza. Alla storia.
Le parole della propaganda ruotano attorno a pochi concetti ben definiti (importa poco la fedeltà non soltanto alla realtà dei fatti, ma addirittura a una qualunque logica); servono infatti per riempire questo vuoto con una presenza che altro non è che dimostrazione di sé, in quanto possibilità di affermare qualche cosa piuttosto che di affrontare gli stessi concetti dialetticamente. Termini come patriottismo, patria (rodina), sicurezza (bezopasnost’), valori tradizionali (tradicionnye cennosti), morale (nravstvennost’) si sono trasformati in formule che indicano l’adesione a una visione in cui la combinazione di certi elementi ha un valore dichiarativo fine a se stesso. Questo accadeva in realtà ben prima del 24 febbraio, ma da quel giorno l’uso funzionale della lingua (in modalità pericolosamente vicine alla langue de bois sovietica) è diventato primario rispetto alla significazione.
Questo tipo di scollamento concettuale si rivela, per esempio, nell’idea stessa di (de)nazificazione di uno stato sovrano, al cui interno gli estremisti di destra sono tanti quanti in Italia o in Germania (se non meno). E certamente meno che in Russia, dove – per fare un esempio – da una quindicina d’anni si tengono le “Russkie marši”, le marce russe, con i saluti romani accanto alle icone e i richiami a “ripulire” le strade da minoranze (etniche, sessuali, ecc.) indegne di stare nella Federazione Russa.
Qui l’elemento pregnante non è il sostantivo, ma l’aggettivo, che da subito presuppone la possibilità di appartenere o non appartenere alla Federazione Russa. Il paese cioè in cui viene regolarmente riscritta la storia, vengono chiusi forzosamente i luoghi che conservano la memoria del passato sovietico (e non solo), in cui dalla metà di marzo i bambini (compresi quelli con disturbi cognitivi) vengono messi in posa in forma di Z per essere immortalati dall’alto a fini propagandistici.
Dalla parte di coloro che si oppongono apertamente alla guerra le parole stentavano a uscire, fin dall’inizio, soprattutto all’inizio; la mattina del 24 febbraio ha portato con sé settimane di considerazioni pubbliche e amicali, in cui ossessivamente ritornava la parola “vergogna”, vergogna per non aver capito dove si sarebbe arrivati, per non aver fermato in tempo la macchina bellica, per non aver capito, per non aver saputo leggere i fatti, i segnali. Vergogna per la Russia, per se stessi, abitanti di quella Russia. Mancavano le parole per razionalizzare, per dare un nome a ciò che stava accadendo, anche e soprattutto a coloro che con le parole ci lavorano: gli scrittori. Questo perché le parole di questa parte sono piene, devono contenere denotati, essere esplicative e quindi preceduta da una comprensione, per quanto parziale, di ciò che accade attorno.
Dopo tre mesi di guerra qualche parola è tornata, molti scrittori, artisti si esprimono con parole chiare, che vanno dalla confessione intima della propria inettitudine all’invettiva aperta, parole comunque insicure o troppo dirette per essere affermazioni personali. Di Jurij Ševčuk, leader di uno dei più celebri gruppi rock russi, le parole “La patria, amici, non è il culo del presidente che occorre continuamente baciare e coprire di bava. La patria è una vecchietta mendicante alla stazione che vende patate. Ecco che cos’è la patria”. Parole dirette, come quelle dei soldati dell’isola dei serpenti (“Nave russa da guerra, vaffanculo!”). Per parlare dell’orrore si sono sempre usate espressioni chiare, dirette, la musica dopo Auschwitz.
Negli ultimi anni in Russia si sono (si erano, sarebbe meglio dire) affermati movimenti di stampo femminista per la difesa delle minoranze sessuali, delle donne, movimenti contro la violenza domestica formati da scrittrici-attiviste, movimenti che necessitavano, cercavano ed elaboravano un linguaggio nuovo, diretto, appunto, risultato dell’urgenza di parlare dell’orrore insito nella vita di tutti i giorni con la lingua di quello stesso orrore, rinunciando molto spesso all’autorialità, a esprimere una posizione personale, in quanto parlare di violenza senza esserne vittima diretta suona quantomeno artificiale.
Ultimamente, ma anche prima del fatidico 24 febbraio, circola tra gruppi ristretti di attivisti, artisti e intellettuali, ma anche su Facebook e Telegram, con sempre maggior insistenza l’idea della necessità di una “decolonizzazione”, il verbo “decolonizzarsi”, alla forma riflessiva (dekolonizirovat’sja), con la coscienza di dover partire da sé, di una ripartenza da zero per riconsiderare il modo in cui si ragione e si vive nel Paese. Dopo questa presa di coscienza le parole torneranno, forse, e torneranno le parole giuste, l’Espressione con la E maiuscola. Forse. Quindi se mancano le parole, viene comunque avvertita in maniera molto acuta la necessità di individuare nuove categorie concettuali, una visione del proprio mondo, in cui il ruolo e il posto della storia e della cultura sia minore rispetto a quello accordato loro dalla narrazione ufficiale.
A ‘denazificazione’ e ‘demilitarizzazione’ manca quindi, rispetto alla triade post-bellica di cui ho parlato in apertura, l’idea della democrazia. Nel discorso del potere russo oggi viene meno l’unico concetto che la propaganda non sa e non può esprimere: una visione di stato e di cittadino senza nome, o il cui nome non si vuole pronunciare, perché sarebbe necessario sostituire al valore della democrazia post-bellica un termine adatto a rappresentare l’idea di un potere anacronistico e assurdo, un termine terribilmente simile a quell’idea di totalitarismo fattuale, di cui la parola “nazisti” oggi, in Russia, non è più sinonimo.
La stessa Russia in cui gli omicidi a sangue freddo di Anna Politkovskaja o Boris Nemcov vengono commentati con frasi come “[Politkovskaja] non avrebbe dovuto immischiarsi, avrebbe dovuto occuparsi dei propri figli”.