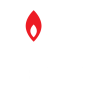27 giugno 2022
Aggiornato 05 ottobre 2022 alle 13:09
Sergej Medvedev è giornalista, scrittore e politologo. Dal 2004 al 2020 è stato docente universitario presso la Higher School of Economics di Mosca. Ha collaborato, fra gli altri, con Forbes, Slon/Republic, TV Rain. Dal 2015 conduce la trasmissione “Archeologija” su Radio Svoboda. Nel 2020 gli è stato conferito il premio della Pushkin House per il suo libro Il ritorno del leviatano russo (non tradotto in italiano). Il presente post è stato pubblicato originariamente in russo su Holod il 3 giugno del 2022, l’originale può essere consultato a questo link. Ringraziamo l’autore e la redazione per l’autorizzazione a tradurlo in italiano.
Tradotto da Giulia De Florio, Luisa Doplicher, Sara Polidoro.
Al centesimo giorno di guerra la capacità di provare stupore e orrore è ormai pressoché nulla, ma poi spuntano nuove prove sulle atrocità dell’esercito russo e nuovamente sprofondi nel baratro.

A inizio aprile, nel villaggio di Termachovka nella regione di Kyiv, i soldati russi avevano fermato per strada cinque giovani del posto e li avevano legati e fatti sedere a terra in un campo, tenendoli così per due settimane, con un mitra puntato. Di notte si arrivava fino a 10 gradi sottozero, nevicava. A uno dei ragazzi avevano sparato alla gamba. Era rimasto disteso per nove giorni con la ferita aperta. Ad un certo punto i soldati hanno portato un morto (nell’originale un “duecentesimo”, in riferimento a ‘Gruz-200’, ovvero ‘Cargo-200’, codice usato nel gergo militare russo per il trasporto di militari deceduti in bare rivestite di zinco, nonché famoso film di cui si parla più avanti nel testo, N.d.T.), il cadavere di un abitante del luogo, gettandolo in mezzo ai ragazzi: “così vi fate un bel sonno tranquillo”.
Probabilmente questi soldati non avranno neanche visto il film “Cargo-200” di Aleksej Balabanov, regista profetico che aveva previsto, tra l’altro, l’avvento del fascismo russo. Eppure simili fantasie aberranti farebbero invidia anche al compianto regista.
Sono tre mesi che in Ucraina assistiamo a un’orgia di violenza epica, smisurata, fatta di fucilazioni di massa e torture brutali, di civili uccisi giusto così, per noia, per divertimento, di stupri e omicidi di genitori davanti agli occhi dei figli e viceversa, di violenza nei confronti di bambine e donne dagli otto agli ottant’anni.
È insostenibile leggere queste storie, ma va fatto: abbiamo l’obbligo morale di provare compassione ed empatia. E dobbiamo anche cercare di capire una cosa: da dove deriva questo male epico portato dall’esercito russo, da quali abissi ctoni, da quali incubi, da quali film dell’orrore esce? C’è forse stata una mutazione genetica in Russia che ha fatto venire alla luce sadici senza scrupoli, giunti ora sul territorio ucraino? I civili sopravvissuti che hanno assistito ai massacri ne parlano non solo con la paura negli occhi, ma anche sbigottiti: “Per la prima volta vediamo una cosa così” (nel testo originale in ucraino, “vperše take bačymo”, N.d.T.), “non pensavamo che fosse possibile una roba del genere”.
D’altronde, non serve essere Fedor Dostoevskij, Jurij Mamleev o Vladimir Sorokin per poter penetrare gli antri oscuri dell’anima russa. Basta seguire i resoconti delle violenze poliziesche e carcerarie, dei crimini dell’esercito, per capire che quanto è accaduto a Buča, Irpin’, nelle altre città e negli altri villaggi occupati dai russi non è un eccesso, né un qualcosa di patologico, si tratta bensì di una sorta di norma, di prassi abituali degli apparati russi della violenza.
I miei colleghi giornalisti di “Proekt” (media indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo, N.d.T.) hanno condotto un’inchiesta sulla storia dei reparti dell’esercito russo di stanza a Buča – il nome di questa località è ormai diventato un nome comune, al pari di Katyn’ e Samaški (rispettivamente l’esercito sovietico nel 1940 e quello russo nel 1995 si erano resi responsabili di massacri in queste località, N.d.T.) – e pare che vi fossero di stanza dei reparti noti per essere particolarmente spietati anche in tempo di pace. Per esempio, la 64a brigata di fucilieri motorizzati della 35a Armata di Chabarovsk gode, in quell’area geografica, di una fama non certo buona: la chiamano la “Mlečnik”, un nome che usano per spaventare i bambini. Si sentono storie di suicidi, di soldati di leva e a contratto che lasciano il reparto a gambe levate; nel giro di sole tre settimane, nel febbraio 2014, nel reparto 51460 dell’esercito dislocato nella località di Knjaz’-Volkonskoe erano morte 7 persone. E la dice lunga il fatto che dopo il ritiro delle truppe russe da Kyiv il presidente Putin abbia conferito a questo reparto il rango di “Guardia”, come per approvare e premiare i crimini di guerra perpetrati. Anche la divisione dei fucilieri motorizzati della 5a Armata, dislocata anche nel Medio Oriente, lascia dietro di sé la stessa scia di violenze militari: spunta sistematicamente nelle storie di crimini, e nelle aree di sua competenza sono stati rinvenuti cadaveri di soldati decapitati.
A Buča non operavano chissà quali mostri (si vociferava di unità speciali della Guardia Nazionale – la Rosgvardija –, di sottoreparti ceceni e sì che anche loro sono coinvolti in feroci massacri), ma unità ordinarie dell’esercito russo che, nonostante tutte le riforme di Anatolij Serdjukov e la poderosa operazione di marketing, continua a utilizzare la brutalità come unico mezzo per comandare. Jeff Hawn della London School of Economics, studioso delle violenze praticate nell’esercito russo, rileva che i crimini di guerra dell’esercito russo nel XXI secolo, dalla Cecenia e dalla Georgia alla Siria e al Donbas (fino all’inizio dell’attuale fase di guerra) sono rimasti impuniti; le forze armate della Russia, a differenza degli eserciti occidentali, non hanno sviluppato una cultura istituzionale che possa contribuire a minimizzare le perdite tra la popolazione civile: l’esercito russo non ha alcun freno che possa scongiurare una violenza ingiustificata e senza controllo. «Le atrocità di questi giorni dell’esercito russo derivano dalla sua connaturata incapacità di sradicare l’eredità del predecessore sovietico», conclude lo studioso. «Le priorità dei soldati russi restano il tasso di nemici uccisi e la vittoria a tutti i costi».
Lo stesso si può dire di altri istituti di potere in Russia: la polizia che fornisce all’esercito sul campo unità delle teste di cuoio (OMON), la Guardia Nazionale, il Servizio penitenziario federale (FSIN). Negli ultimi anni, grazie alla diffusione di telefoni e tablet nei luoghi di reclusione e all’accessibilità dei social network, si sono riversati sugli utenti terabyte di testimonianze scioccanti di torture, sevizie e violenze che da decenni vengono perpetrate nelle prigioni russe e che sono ormai diventate la norma nei rapporti tra l’amministrazione e i detenuti e dei detenuti tra di loro.
Ora a combattere in Ucraina ci sono contrattisti prelevati dalle regioni più depresse e ad alto tasso di criminalità della Russia dove tra la popolazione maschile domina la subcultura carceraria: la maggior parte di loro è stata dentro o ha avuto parenti e conoscenti al fresco, gli adolescenti finiscono attirati nella rete dell’A.U.E. (organizzazione segreta e informale di criminali russi, per lo più bambini e ragazzi, spesso gestita da criminali adulti, N.d.T). Questo modus vivendi con le sue “regole” e pratiche di estrema violenza fisica e a sfondo sessuale ora si è trasferito nei territori occupati dell’Ucraina: l’inaudita brutalità della reclusione ha sfondato le barriere della colonia penale e i confini del Paese.
D’altro canto la violenza non si limita ai soli enti governativi, ma prolifica nelle famiglie, nei rapporti tra uomini e donne, genitori e figli, vecchi e giovani, capi e sottoposti. Prorompe nelle intercettazioni telefoniche tra i militari russi e i loro comandanti – in cui è tutta una profusione di bestemmie, minacce, offese –, nelle chiamate e nelle lettere dei soldati alle proprie famiglie dove il sentimentalismo patetico si mischia alla crudeltà e al cinismo: mogli che consigliano ai soldati che cosa arraffare nelle case degli ucraini e di che misura rubare le scarpe, mogli che suggeriscono: “violenta pure le ucraine, ma prendi precauzioni”.
La violenza è penetrata nella carne e nel sangue della società russa, è diventata la matrice di una collettività costruita su gerarchie e sottomissioni, sulla sottrazione e la distribuzione delle risorse in cui la forza bruta è ben al di sopra della morale e il potere vince sul diritto. Tale ordine è consacrato dal comportamento della classe dirigente che dà alla plebaglia le sue automobiline con i lampeggianti, che esce impunita dai tribunali, che viene immortalata nei discorsi del presidente Putin, il quale insegna che «i deboli si picchiano» e «bisogna farlo per primi», strappando così gli applausi della folla.
In genere questa violenza è riservata all’uso interno: sostiene e legittima l’ordine sociale e politico del paese. Ma ora assistiamo al primo utilizzo di massa, in cui dilaga al di là dei confini del paese, insieme a un esercito invasore di 200.000 soldati; questa violenza ha il benestare dello stato e una base ideologica. Quando Putin cita «nazisti e drogati», espressione pescata in mezzo a falsità propagandistiche (che devono essere la sua principale fonte di informazioni sul mondo oltre i confini del bunker), i soldati delle forze occupanti lo prendono alla lettera, irrompono nelle case ucraine e chiedono ai proprietari stupiti: «Dov’è che stanno i nazisti qui?», oppure, come testimoniano gli abitanti del villaggio di Termachovka già citato, si meravigliano: «Gli abbiamo spezzato le dita e lui non ha neanche fatto una smorfia, doveva proprio essere drogato!».
Se cerchiamo di capire che cosa c’è dietro le atrocità degli occupanti russi in Ucraina, ci accorgiamo che non è una questione di sadici e razziatori isolati; il problema è nella struttura stessa della Russia.
Se proseguiamo con la metafora militare, la Russia è cucita come un cappotto. Non quello di Akakij Akakievič (protagonista della novella omonima di Gogol’ N.d.T.), da cui è uscita tutta la letteratura russa, ma un semplice cappotto da soldato, uno degli archetipi elementari di una nazione perennemente in guerra. L’abito ha un diritto e un rovescio. Fuori è grezzo, ruvido e consumato dai secoli, ci sono gli spazi aperti, l’impero, le dimensioni, la guerra, i carri armati e gli aerei, la bomba atomica, il cosmo, la cultura, Mosca e San Pietroburgo, le chiese e i palazzi. Dentro, nello spazio invisibile al mondo ma vicino al nostro corpo, ci sono la schiavitù, la beceraggine, i ladrocini, le bugie, il dispotismo e l’inesorabile brutalità della vita russa. Noi siamo abituati a tutto ciò e lo portiamo addosso, scrollandoci e grattandoci ogni tanto; qualche patriota crede addirittura che sia il prezzo da pagare per la nostra grandezza, e sotto sotto è fiero che la vita russa sia strutturata così: pazienza se l’orto è pieno di erbacce e tocca fare i bisogni all’aperto; in compenso abbiamo il balletto, la letteratura, l’anima misteriosa e un grande impero.
Ma ora è successo uno scandalo: secondo la celebre espressione di Dostoevskij, la Russia si è «denudata», il cappotto è stato rovesciato ed è apparsa in bella vista la pochezza intrinseca sotto forma di un «esercito invasore»; il mondo ha visto la Russia in tutta la sua cattiveria insensata, crassa ignoranza, tendenza generale a rubare, brutalità, violenza e disprezzo della dignità individuale e della vita umana, che si tratti di civili ucraini o dei propri stessi soldati. Quelle caratteristiche ormai abituali dentro il paese, come un marchio di fabbrica, tutt’a un tratto sono diventate visibili: sono venuti fuori tutti i buchi, gli strappi, le cuciture storte, il tessuto mezzo marcio del cappotto russo, e ormai non è un crollo della reputazione, ma della civiltà stessa. Viene minata alla base la finzione su cui si è retta la Russia negli ultimi secoli: la forma esterna del paese, manifestatasi in questa guerra vergognosa, corrisponde ora al suo contenuto interno; la Russia si è presentata al mondo nel suo vero aspetto. Il male senza fondo scoperto a Buča e Mariupol’ può far inorridire, ma non deve meravigliare: tutta la Russia è la nostra Buča.