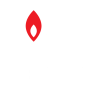15 giugno 2022
Aggiornato 05 ottobre 2022 alle 13:07
Giulia De Florio conversa con Niccolò Pianciola, storico dell’Università di Padova e membro del consiglio direttivo di Memorial Italia, sul libro di Sergej Abašin Qishloq. Il secolo sovietico in una valle dell’Asia centrale, Roma, Viella, 2022.

Come e quando è nata l’idea del libro di Sergej Abašin che hai appena curato per Viella?
Si tratta della traduzione italiana – in una versione ridotta dall’autore stesso – di Sovetskij kišlak: meždu kolonializmom i modernizaciej [Il kišlak sovietico: tra colonialismo e modernizzazione] (Mosca, 2015), la più importante monografia storico-antropologica sull’Asia Centrale che sia stata scritta in Russia negli ultimi trent’anni. Il libro, tradotto da Emanuela Guercetti, è frutto della pluriennale ricerca di Sergej Abašin che si è sviluppata durante due periodi: il primo, più lungo, intorno alla metà degli anni Novanta; il secondo più breve nel 2010. È un lavoro significativo non soltanto per la sua qualità, ma anche perché è pienamente inserito nel dibattito antropologico e storiografico internazionale.
Che cosa significa Qishloq e perché Abašin lo ha scelto come “protagonista” del suo studio?
Qishloq in uzbeco significa villaggio. L’oggetto della ricerca è infatti Ošoba, un grosso villaggio uzbeko in Tagikistan, nella valle del Fergana, abitato alla fine del secolo scorso da circa 700 famiglie. Il fatto che ci siano villaggi uzbechi in Tagikistan non deve far pensare che Lenin e Stalin abbiano tracciato i confini delle repubbliche centroasiatiche con l’esplicito intento di ingarbugliare i confini amministrativi per meglio dominare le diverse popolazioni, insomma un divide et impera sovietico, come si sente molto spesso ripetere. In realtà, i confini delle “repubbliche nazionali sovietiche” nella regione sono stati tracciati negli anni Venti sulla base delle divisioni etniche della popolazione rurale così come erano interpretate da etnografi e amministratori centroasiatici, che organizzarono indagini etnografiche allo scopo. Non fu però sempre possibile rispettare questo criterio, per ragioni legate ad esempio alla gestione delle risorse idriche e alla posizione delle vie di comunicazione. Dunque, in tutte le repubbliche sovietiche tra cui venne divisa l’Asia Centrale rimasero significative minoranze la cui etnicità coincideva con la “nazione titolare” degli stati confinanti: Ošoba è uno di quei casi. Il villaggio si trova nella valle del Fergana, il centro demografico ed economico dell’intera Asia Centrale, divisa nel 1924 tra Uzbekistan, Tagikistan (allora una “repubblica autonoma” all’interno del primo) e Kirghizistan.
Qual è l’approccio seguito da Abašin e in che modo si è evoluta, a livello metodologico, la storiografia che tratta il periodo sovietico?
Lo studio di Abašin è ormai molto lontano dall’approccio dell’etnografia tardosovietica, alla cui scuola si era formato. Abašin si è lasciato alle spalle sia la fiducia della prima antropologia sovietica in un progresso lineare in cui le “sopravvivenze” culturali di epoche passate non possono che essere un fenomeno temporaneo, sia il superficiale giudizio degli etnografi del periodo gorbacioviano su una vittoria della “tradizione” e sul fallimento della modernità sovietica. L’antropologo investiga invece i significati di rapporti e figure sociali prerivoluzionarie in una società trasformata dalle nuove istituzioni sovietiche e dalle nuove gerarchie attribuite dallo stato alle diverse sfere del sociale. Paradigmatico in questo senso il capitolo sui “discendenti dei santi” e le loro variegate categorie di gruppo. Tra l’altro Abašin mostra come queste ultime abbiano significati e relazioni gerarchiche differenti in diverse regioni dell’Asia Centrale. Un’altra prova, per l’etnografo moscovita, della necessità di abbracciare uno sguardo “locale”. Lo “sguardo locale” di Abašin è un approccio etnografico o microstorico grazie al quale la “descrizione densa” alla maniera di Geertz delle strategie di attori sociali, e dei significati che essi attribuiscono alle categorie riferite a una comunità limitata, permette di analizzare le questioni della continuità e del cambiamento nei rapporti di potere e status, e nelle pratiche culturali. Questo approccio permette inoltre di studiare la “sovieticità” e “colonialità” delle diverse generazioni della comunità di Ošoba contestualizzando emozioni, lealtà, uso dell’ideologia, ruoli di genere.
A quali domande tenta di rispondere lo studio di Abašin e quali temi invece tralascia e andrebbero indagati?
Una domanda importante cui Abašin risponde è quella che è stata ben formulata da Artemy Kalinovsky in una recensione a Sovetskij kišlak: “C’era una differenza tra sovieticità e russità/europeità? Se è così, questo implica che l’Urss stava davvero creando qualcosa di nuovo che andava oltre l’imposizione di pratiche e forme di conoscenza ‘occidentali’ nella loro permutazione sovietica. Se non è così, questo significa che al massimo l’Unione Sovietica creò possibilità di coesistenza che forse non erano così diverse da altri contesti imperiali”. La risposta di Abašin all’interrogativo è senz’altro positiva: a differenza di altre “formazioni imperiali”, il progetto sovietico di uniformazione a modelli culturali comuni, e il senso di appartenenza che riuscì a creare nel periodo postbellico rendono l’esperienza dei cittadini tardosovietici decisamente diversa da quella dei sudditi dei moderni imperi coloniali. Sebbene Abašin noti come la maggioranza degli abitanti di Ošoba che lui aveva conosciuto negli anni Novanta rifiutasse la categoria di “colonialismo” riferita al periodo sovietico, l’etnografo moscovita ritiene che l’Urss conservò sempre anche una dimensione imperiale. Tale persistenza è sottolineata anche da altri studi che hanno invece per oggetto contesti urbani, come il libro che Marco Buttino ha dedicato a Samarcanda nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale. È vero che, pur in un libro già imponente, alcuni aspetti della vita sociale del villaggio restano fuori dallo studio di Abašin. Non si parla, per esempio, della questione dell’educazione, della scuola, e della parziale russificazione che era un aspetto importante dello sviluppo di una comune cultura sovietica nelle diverse regioni dell’Unione; né si analizzano le trasformazioni dell’economia agricola.
È possibile che una “microstoria” come quella di un villaggio dell’Asia centrale possa aiutare a capire i meccanismi che regolavano il sistema di potere sovietico e, in definitiva, il funzionamento dell’intera URSS?
Assolutamente sì. Quest’opera è, in un certo senso, una microstoria del “secolo sovietico”. Questo rende il libro molto interessante, io credo, anche per chi non sia specificamente incuriosito dalla storia dell’Asia Centrale. Così come in quello sui “discendenti dei santi”, anche negli altri capitoli Abašin analizza categorie e istituzioni nella concretezza delle diverse configurazioni di potere nei vari periodi della storia sovietica, guardando a come furono plasmate da decisioni prese al Cremlino, dalle diverse fasi delle politiche economiche, e dalle personalità che ricoprivano cariche amministrative a livello locale. Abašin riesce a mostrare come le categorie introdotte dal potere sovietico diventino “emiche”, ovvero siano interiorizzate dagli attori e ne influenzino l’agire sociale, “ibridando” concetti, valori, e simboli di status precedenti alla creazione del sistema, culturale e di potere, sovietico. Del resto, le facce dello stato comunista nel villaggio nei diversi periodi sono immerse nella società di Ošoba. In questo senso è emblematica la figura del “piccolo Stalin”, Ortyk Umurzakov, protagonista di uno dei capitoli. In un libro che copre tutta l’era sovietica, il lettore di fatto non si imbatterà mai in un nome russo. Gli attori sono tutti centroasiatici: i costruttori della nuova società sovietica, gli interpreti dei nuovi linguaggi, gli oppressori, le vittime, gli amministratori. Naturalmente ciò non esclude che, in alcuni periodi, specifiche politiche decise a Mosca non fossero distruttive per gran parte della popolazione di alcune regioni. I kazachi, in particolare, andarono incontro a una ecatombe per fame all’inizio degli anni Trenta, durante una carestia provocata dalle politiche estrattive del nascente sistema economico e sociale staliniano impegnato in un caotico e feroce consolidamento.
Quali sono, secondo Abašin, le differenze fondamentali nei vari periodi storici che affronta (anni Venti e Trenta, post-stalinismo, era brežneviana etc.) dal punto di vista dell’appropriazione e negoziazione dell’identità sovietica?
Questo è un aspetto importante perché secondo me è proprio lo sguardo di medio-lungo periodo di Abašin, che abbraccia anche la lunga stagione post-staliniana, a rendere la sua analisi originale e importante. Sebbene “sovietizzazione” dall’alto e appropriazione e negoziazione dell’identità sovietica dal basso ebbero un loro corso fin dagli anni Venti, Abašin mostra come sia stato il periodo post-staliniano ad essere cruciale per la “normalizzazione della sovieticità” in Asia Centrale, ancora più della Seconda guerra mondiale. Fu negli anni Sessanta che la scolarizzazione elementare e i servizi del rudimentale welfare sovietico (ad esempio la sanità pubblica) raggiunsero quasi tutte le fasce della popolazione, anche quella rurale delle zone più isolate. La fine del periodo chruščëviano e l’inizio di quello brežneviano furono uno spartiacque storico anche per le trasformazioni del paesaggio agrario e per lo sfruttamento delle risorse, in primis idriche. Come altre ricerche hanno messo in rilievo, è stato tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta che in Asia Centrale iniziò un enorme incremento della superficie messa a coltura, grazie alla frenetica espansione dei canali di irrigazione a tutti i livelli: dal gigantesco canale Qaraqum, che finì per essere il fattore più importante nel processo di disseccamento del Mare d’Aral, ai piccoli canali costruiti dai kolchoziani. Ancora una volta, la microstoria kolchoziana di Abašin fornisce un nuovo punto di vista su un vasto macroprocesso, mostrando come fosse l’iniziativa dal basso di presidenti di kolchoz decisi a espandere la propria rete di irrigazione che portò alla costruzione di canali né pianificati né tanto meno approvati dalle istanze amministrative superiori dell’economia di comando sovietica. Queste ultime, per lo meno nel caso studiato da Abašin, si limitarono a “legalizzare” quanto era stato fatto, e a convogliare ulteriori investimenti nell’area proprio grazie ai lavori “illegali” realizzati dagli intraprendenti direttori delle fattorie collettive. Insomma, grazie sia al suo “sguardo locale”, sia al fatto che abbraccia quasi cent’anni, il libro di Abašin riesce ad essere molto di più di un’etnografia storica di un villaggio. È la storia dell’Asia Centrale sovietica vista da un villaggio: la microstoria di Ošoba finisce per fornire al lettore uno sguardo diverso sulla più generale storia sovietica.