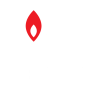(di Alessandro Catalano, professore di lingua e letteratura ceca presso l’Università di Padova e candidato socio di Memorial Italia)
25 maggio 2022
Aggiornato 04 ottobre 2022 alle 09:16
Il grande merito dell’opera, Un Occidente prigioniero o la tragedia dell’Europa centrale (Adelphi), è quello di disegnare un’idea d’Europa in cui non ci sono paesi occidentali (Austria) e orientali (Cecoslovacchia), ma un’unica matrice culturale comune.
Alcuni scrittori hanno la capacità di cogliere aspetti poco visibili della realtà che ci circonda e suscitare discussioni non superficiali su questioni politiche di grande complessità. Adelphi ha portato in questi giorni nelle librerie italiane un saggio estremamente attuale di Milan Kundera, Un Occidente prigioniero o la tragedia dell’Europa centrale. Il volumetto, uscito da Gallimard nell’autunno scorso, contiene due testi, entrambi reperibili solo a fatica in italiano, il discorso al IV Congresso degli scrittori cecoslovacchi nel 1967 e uno dei suoi interventi pubblicistici più noti in assoluto, dedicato alle conseguenze del “ratto dell’Occidente”. Si tratta di un testo subito tradotto in molte lingue, che ha avuto gran diffusione alla metà degli anni Ottanta e ha contribuito, come ha sottolineato lo storico Jacques Rupnik, “a rimodellare la mappa mentale dell’Europa” (in Italia era stato a suo tempo pubblicato col titolo Un Occidente sequestrato su Nuovi argomenti).
Ma perché Kundera accusava nel 1983 l’Occidente di disinteressarsi di quanto accaduto nella parte dell’Europa finita nella sfera d’influenza dell’Unione Sovietica? In un mondo diviso in blocchi contrapposti, che cosa avrebbe dovuto fare l’Occidente? È importante aver presente che la polemica di Kundera non verteva su un’idea intoccabile della geopolitica bipolare, ma affrontava coraggiosamente la questione culturale di fondo: che cos’è l’Europa? Oggi sono di nuovo in discussione le mappe politiche e culturali del continente ed è in gioco molto più che il destino di una regione lontana, fuori dagli interessi di molti esperti internazionali, è un discorso che torna a essere di grande attualità. La domanda che poneva Kundera è infatti se l’Europa sia solo una mera unione geografica di paesi (oggi diremmo economica) o rappresenti un insieme di valori condivisi. Allora poteva sembrare velleitaria, ma non lo sarebbe stata più appena sei anni dopo, al momento del fragoroso crollo del comunismo che ha messo in moto una completa riorganizzazione politica del continente.
Viste dall’esterno anche le questioni all’apparenza più semplici appaiono in prospettive nuove e la cultura non fa certo eccezione. Già Italo Calvino, recensendo l’Insostenibile leggerezza dell’essere, aveva definito Milan Kundera un autore che dall’Europa dell’Est osservava gli intellettuali occidentali “con l’impassibile oggettività d’un etnologo che studi i costumi d’un abitante agli antipodi”. La stessa impressione può suscitarla anche Un Occidente prigioniero, uscito in francese nel novembre del 1983 su “Le Débat”. In un momento in cui l’Europa era spaccata da una cortina che sembrava eterna, Kundera si chiedeva cosa resta dell’Occidente nel momento in cui rinuncia alla parte centrale dell’Europa.
Va ricordato che per molti i paesi dell’Europa centrale rappresentavano allora poco più di varianti del mondo indecifrabile dell’est comunista, “nascoste dietro la cortina di lingue bizzarre e poco accessibili” e quindi lontanissime dall’Occidente. Oggi quel confine si è spostato più a oriente, sono coinvolte negli stessi meccanismi di appartenenza/esclusione altre parti d’Europa, ma l’atteggiamento è rimasto sostanzialmente lo stesso. Per Kundera invece la questione centrale era che cosa succede alla nostra identità nel momento in cui una parte d’Europa viene abbandonata a chi ha il potere di occuparla. Una domanda provocatoria allora, come oggi, in un momento peraltro in cui non risulta più preponderante la contrapposizione tra sistemi politici alternativi, il capitalismo e il comunismo.
Non è sorprendente che sia stato proprio uno scrittore di radici ceche a lanciare l’allarme rispetto alla sparizione dell’idea di unità culturale dell’Europa. La Primavera di Praga, della quale Kundera era stato uno dei protagonisti in campo culturale, era stata infatti repressa nell’agosto del 1968, con una strategia che ricorda da vicino le modalità portate avanti nella prima fase dell’invasione dell’Ucraina. Kundera viveva da anni in Francia e l’Europa centrale sembrava ormai definitivamente uscita dall’Occidente e poco compresa dagli intellettuali che la osservavano al di qua della cortina. Da ciò la sua visione netta: “oggi l’Europa centrale è asservita alla Russia”.
L’appassionata, quasi angosciata, difesa di uno scrittore che era al vertice della sua notorietà internazionale parte dalle parole diffuse dal direttore dell’agenzia di stampa ungherese nel 1956 (“Moriremo per l’Ungheria e per l’Europa”). Perché una frase del genere proprio in uno dei paesi che “sono scomparsi dalla carta dell’Occidente”? Che senso potevano avere quelle parole nel 1956? L’idea di Kundera, piuttosto indulgente rispetto al sostegno attivo fornito dalle élite culturali locali nell’imposizione del comunismo, è che cechi, polacchi e ungheresi fossero imprigionati da catene culturali imposte dall’esterno, come dimostrava anche il fatto che periodicamente venissero messe in discussione dal “lungo periodo delle rivolte centroeuropee” (1956, 1968, 1970). Diritti umani, stili di vita e valori europei non dipendono infatti soltanto dall’appartenenza a una sfera di influenza, qualunque essa sia, ma possono essere perseguiti anche da chi appena pochi anni prima poteva sembrare lontano e indifferente.
Il testo si pone obiettivi ambiziosi, a partire dalla definizione di Europa centrale (“l’incerta zona di piccole nazioni strette tra Germania e Russia”), e finisce spesso su un terreno scivoloso, che ha suscitato molte discussioni. Più che come saggio scientifico va chiaramente letto come una riuscita provocazione. L’idea stessa di identità centroeuropea come multiculturale e transazionale è stata infatti da allora oggetto di ripetuti tentativi di definizione, spesso poco convincenti. La discussione sui confini esterni dell’identità immaginata da Kundera è naturalmente aperta e si fa tanto più problematica quanto più coinvolge paesi che, per cultura, religione e storia, sono sempre stati eccentrici rispetto a quest’idea idealizzata di Europa centrale, non solo in casi come la Bulgaria, ma anche in fondo la Germania e, naturalmente, l’Ucraina.
Il grande merito del saggio Un Occidente prigioniero è però quello di disegnare, tra i primi, un’idea di Europa in cui non ci sono paesi occidentali (Austria) e orientali (Cecoslovacchia), ma un’unica matrice culturale comune. A decidere il campo di appartenenza di un paese o dell’altro è questo criterio e non certo l’imposizione del dominio di un altro paese con la forza.
La storia culturale dei secoli passati è ricostruita da Kundera in modo creativo, a partire dal presupposto che “l’Europa centrale non è uno Stato, ma una cultura o un destino” e che “i suoi confini sono immaginari”. Si tratterebbe sostanzialmente di un insieme di stati in cui permangono “la medesima memoria, la medesima esperienza, le medesime tradizioni comuni”, nonostante nella storia abbiano dato vita a formazioni statali molto diverse tra loro. Per rendere possibile la costruzione di un’identità di questo tipo, che con grande fatica è stata poi perseguita senza particolare successo dopo il 1989 dai quattro paesi del gruppo di Visegrád, l’autore non può naturalmente accettare “l’ideologia slava”, che viene liquidata come costrutto o “mistificazione politica” del XIX secolo. Kundera a questo proposito ricorda le parole del giornalista ceco Karel Havlíček, che dopo una fase di avvicinamento alla Russia, si era trasformato in uno dei suoi maggiori critici: “ai russi piace definire slavo tutto ciò che è russo, in modo da poter poi definire russo tutto ciò che è slavo”.
Già nell’intervento nel giugno del 1967 al citato congresso degli scrittori, Kundera aveva affrontato il tema della continua lotta per l’esistenza che le “piccole nazioni” devono sempre affrontare e dei rischi corsi dalla cultura ceca, spinta alla periferia dell’Europa. Ancora più esplicito era stato nell’articolo Il piccolo e il grande, dei primi giorni di agosto del 1968, quando ormai le nubi si addensavano sulla Cecoslovacchia. Le continue pressioni di Mosca avevano infatti reso puramente virtuali i proclami sui rapporti fraterni: tutta la buona volontà dei politici cechi “non è comunque un’arma del pari contro il pari, ma del piccolo contro il grande, del minacciato contro chi minaccia”. La Cecoslovacchia si trovava in una situazione critica e il rapporto con la Russia rischiava drammaticamente di trasformarsi da quello di “alleato volontario di una grande potenza una volta tanto amata” a quello di un paese prigioniero di un “destino estraneo, imposto, derivato”.
I carri armati e la vuota retorica propagandistica, che accompagna da sempre l’azione bellica, hanno poi il 21 agosto reciso definitivamente tutti i legami culturali: “la prima conseguenza dell’occupazione della Cecoslovacchia da parte dei russi fu la totale distruzione della cultura ceca in quanto tale”. Per ricorrere al celebre paragone, poi molto abusato, con cui Louis Aragon aveva presentato Lo scherzo in Francia, la Cecoslovacchia stava per essere ridotta a “un Biafra dello spirito”. Ma nelle parole di Kundera si coglie anche l’eco del famoso discorso di Neville Chamberlain sulla Cecoslovacchia del 1938 in cui, dopo la famigerata conferenza di Monaco, rifiutava la guerra per “un paese lontano di cui sappiamo poco”. E non è la stessa incomprensione che risuona nelle parole del povero direttore dell’agenzia di stampa ungherese? Un intellettuale che, “perché l’Ungheria restasse Ungheria e restasse Europa, era pronto a morire”? E non è l’essenza di molte delle odierne discussioni a proposito dell’Ucraina?
Pagine significative dell’Occidente prigioniero sono naturalmente dedicate alla Russia che “sta smarrendo anch’essa la sua identità”. Se la tradizione imperialista è meno visibile altrove, “ai confini orientali di quell’Occidente che è l’Europa centrale, siamo sempre stati più sensibili al pericolo della potenza russa”. È in quella parte d’Europa, infatti, che “percepiamo, meglio che altrove, la Russia come un Antioccidente”. Per Kundera sembra che anche la storia del comunismo russo vada reinterpretata: in parte può essere vista come la sua negazione (per esempio per quanto riguarda l’aspetto religioso), ma al tempo stesso rappresenta anche il “coronamento delle sue tendenze centralizzatrici e dei suoi sogni imperiali”. Agli occhi di Milan Kundera la Russia rappresenterebbe “il minimo di diversità nel massimo spazio”, mentre l’identità europea “il massimo di diversità nel minimo spazio”. E la situazione non sembra oggi particolarmente mutata. Ma si può davvero leggere la storia degli ex paesi dell’est come una variante dell’imperialismo russo, come riteneva lo scrittore ceco-francese? È un punto che andrà in ogni caso discusso e forse gli avvenimenti degli ultimi mesi ci costringeranno a ripensare in termini diversi anche all’interpretazione della storia del XX secolo.
Attorno alla metà degli anni Ottanta, Milan Kundera ha affrontato polemicamente una serie di questioni, oggi tornate di estrema attualità, attorno alle quali troppo spesso gli esperti di culture slave si muovono con circospezione. Sulle pagine del “New York Times Book Reviews”, nel gennaio del 1985, in quella che in italiano è pubblicata come prefazione alla pièce Jacques e il suo padrone, dichiarava per esempio di provare, a differenza dell’amato Čechov, gran fastidio nei confronti del “clima” dei romanzi di Dostoevskij. La proposta di un regista di realizzare una riduzione teatrale dell’Idiota, che avrebbe poi firmato a suo nome in un momento in cui Kundera non poteva più pubblicare ufficialmente le proprie opere, gli aveva provocato un sentimento di nausea nei confronti di “quell’universo di gesti eccessivi, di profondità oscure, di sentimentalismo aggressivo”. A quello che ha spesso definito “anima slava” Kundera contrapponeva il razionalismo di Diderot. Anche se il discorso verteva in realtà su certe implicazioni filosofiche di una parte della cultura russa e non sul suo valore estetico, le sue parole suscitarono la replica sprezzante del poeta russo Iosif Brodskij, che da lì a poco sarebbe stato insignito del premio Nobel.
È interessante rileggere oggi, nel contesto dell’invasione dell’Ucraina, quella discussione, visto che, per utilizzare un termine così caro oggi ai rappresentanti del Cremlino e che andrebbe usato con maggiore cautela rispetto a quanto si sente spesso anche in Italia, la posizione di Kundera sarebbe senz’altro etichettabile come “russofobia”. Si potrebbe però anche ritenere che, se determinate domande vengono riproposte a distanza di tempo, forse è anche perché le risposte non sono state del tutto soddisfacenti.
Al di là dei passaggi discutibili (che cos’è per esempio “la civiltà dell’Est”?) e al ruolo ricoperto da Kundera stesso negli anni Cinquanta nel consolidamento di quello stesso sistema politico, Un Occidente prigioniero pone un insieme di questioni rilevanti rispetto all’“Europa della cultura”. Se volessimo utilizzare la terminologia estremizzata dello scrittore ceco-francese, ci si potrebbe chiedere perché sembrano di nuovo disposte a morire per i valori fondanti dell’Europa proprio le élite di quei paesi che fino a pochi mesi fa sembravano “meno europei” degli altri?
Alcuni dei temi affrontati da Kundera sono oggi tornati di grande attualità e meriterebbero di essere discussi in una prospettiva più ampia. Il punto cruciale del discorso di Kundera è infatti che quello che si stava svolgendo allora non era solo un inevitabile conflitto basato sulle ferree leggi della geopolitica, ma “la sua vera tragedia non è dunque la Russia, ma l’Europa”. Peccato che molti non l’hanno capito allora e non sembrano rendersene conto nemmeno stavolta.